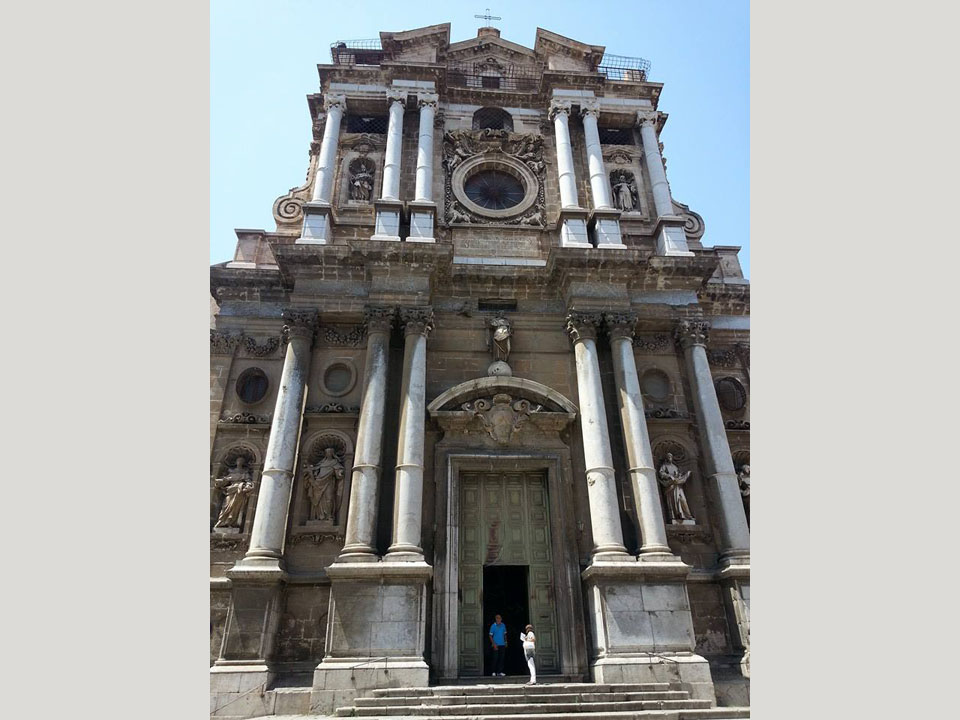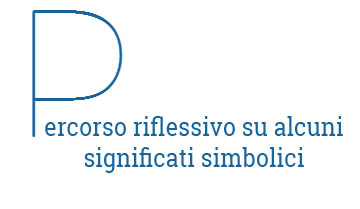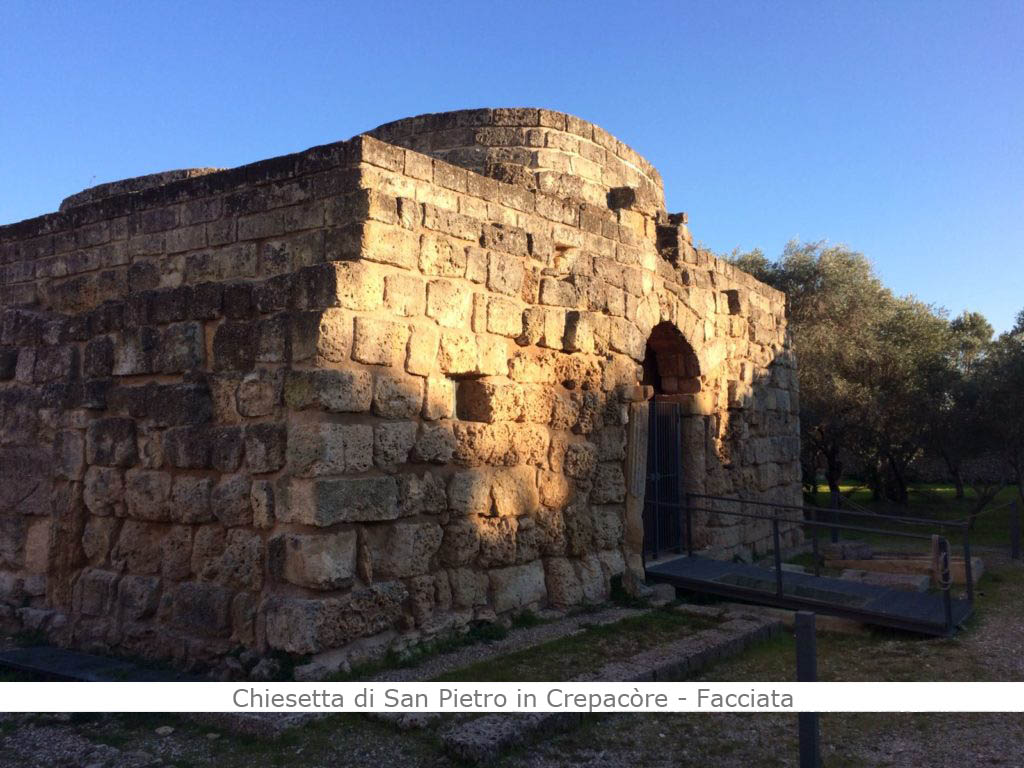IL SUD È UN DONO?


Chiedo a Valeria Parrella, scrittrice napoletana tra le più interessanti del panorama letterario contemporaneo, e feconde nella capacità di creare immaginari esistenziali e di indagare l’animo umano.
Nulla è irrinunciabile, ma mi fa fatica pensare a una divinità, non sono abituata.
Allora facciamo che posso portare in dono a un extraterrestre qualcosa del sud, mhh, vediamo gli porterei una pianta di limone, una di ulivo e una di vite. Così posso tenerne altre strette a me.
Valeria Parrella ha nelle corde sia il respiro profondo del racconto (“Mosca più balena” con cui nel 2003 esordisce per Minimum fax, a cui segue per la stessa casa editrice “Per grazia ricevuta”, e ancora “Troppa importanza all’amore” per Einaudi) sia l’ampiezza dello sguardo del romanzo: “Lo spazio bianco”, “Lettera di dimissioni” e “Tempo di imparare” pubblicati con Einaudi; “Ma quale amore” con Rizzoli, poi ripubblicato nei tascabili Einaudi; e da pochi giorni di nuovo in libreria con “Enciclopedia delle donne. Aggiornamento”, un romanzo “scostumato” come me l’ha definito lei stessa. La sua produzione attinge anche alla polifonia del teatro, la molteplicità e l’effetto scenico delle parole: “Il verdetto”, “Ciao maschio” e “Euridice e Orfeo” per Bompiani; “Tre terzi”, insieme a Diego De Silva e Antonio Pascale, e “Antigone” per Einaudi; nel 2011 il libretto “Terra” su musica di Luca Francesconi.
Valeria Parrella ha il dono di una scrittura che misura con grazia e attenzione maniacale il peso delle parole, che scava nei diversi registri linguistici, letterari e non solo, per portare alla luce prospettive e visioni inedite dell’interiorità
Capace di presentare personaggi che nella loro individualità assurgono a emblemi di una condizione esistenziale universale.
Nei tuoi romanzi i luoghi non prendono mai il sopravvento, sono sempre filtrati dai personaggi e dalla loro percezione emotiva. Penso ai posti frequentati dalla madre in “Tempo di imparare” o a quelli vissuti dalla protagonista di “Lo spazio bianco”. Forse una loro più forte caratterizzazione c’è in “Lettera di dimissioni”, che tra i tuoi libri è quello in un certo senso più “civile” e meno introspettivo. Con “Ma quale amore” dalla Napoli dei romanzi precedenti la scrittrice protagonista passeggia per le strade di Buenos Aires, il sud letterario per eccellenza. Nei racconti invece il tuo orizzonte geografico appare più vario. Che valore hanno i luoghi, quelli meridionali in particolare, nella tua narrativa? È fuorviante osservare che nei romanzi rimani più ancorata a Napoli, e nella forma del racconto “emigri” in altri luoghi, senza mai lasciare veramente la città partenopea? Si potrebbe arrivare a ipotizzare, anche attraverso i luoghi narrati, che nei romanzi Valeria Parrella regala più della sua autobiografia, e nei racconti invece il distacco è più netto?
L’unico problema è Napoli, intendo come luogo tutto, geografico e umano. Perché tra teatro letteratura cinema e televisione capisci che archetipo e stereotipo comune che ne abbiamo e a cui bisogna sempre cercare nuove smussature, facce nascoste, o rifiutarlo…insomma un casino. Il resto del sud, la provincia per esempio non mi spaventa quanto Napoli.
Il mio sistema è non verificare, lasciare che il ricordo abbia il sopravvento sulla realtà. Insomma spaesarmi.
Rispetto all’autobiografismo non sono d’accordo. No: credo che siano profondamente autobiografici i temi che tratto, nello spazio di una racconto o di un romanzo, o di una piece teatrale. Alla fine mi interessano cinque o sei cose e tutta la mia produzione è una declinazione di queste. Gli avvenimenti, cioè le storie che racconto invece non sono MAI autobiografici. Non c’è una, per dire, delle mie voci narranti, non c’è un IO che sia davvero mai stata io.
Le tue meravigliose donne: non ce n’è una che non sia stata un po’ ME. Non è forse questa la forza straordinaria della letteratura: non parlare di sé ma parlare al sé, che è in ciascuno? I tuoi libri sono molto amati, tradotti e i testi teatrali rappresentati in molti luoghi: veicolano un’idea di sud o l’appartenenza a una geografia narrativa e letteraria non ti interessa? Ti senti in un certo senso di rappresentare come scrittrice una nozione di sud, e quale?
Allora: a me non interessa, cioè nel momento in cui scrivo non ho un obiettivo, non mi interessa di nulla e di nessuno. Se poi a posteriori arriva questa idea di sud e di donne mi va benissimo, visto che sono una donna del sud.
Mi chiedo ad esempio se la madre di “Tempo di imparare” non sarebbe una donna o una madre diversa lontana da Napoli,
e lo stesso per Clelia, di “Lettera di dimissioni”, se la sua vicenda professionale non sia straordinariamente legata a una certa “politica” caratteristica, anche se non unica, del meridione. No, non credo. “Tempo di imparare” è un romanzo così intimo che non ha collocazioni spazio temporali, e ho conosciuto tante donne nel mondo e fuori dal mondo (detenute per esempio) con bambini disabili e ti dico che la geografia non c’entra nulla. Anche per Clelia non credo: quella politica lì non appartiene al sud, appartiene alla ex sinistra e a Roma o a Milano è uguale. Certo, Clelia non potrebbe essere una scandinava, questo sì. Ma in Italia potrebbe stare dappertutto.
Quale delle tue protagoniste, includendo anche le eroine mitiche come Antigone ed Euridice, è più necessaria oggi al sud, e con chi l’accompagneresti?
Scelgo la protagonista di “Lettera di dimissioni”, Clelia: una donna dal passato comunista, che deve ricollocarsi nello spazio e nel tempo. Credo che quello sia il mio vero romanzo civile. E la farei andare a cena con Jane Eyre.
“Sono una donna del sud”: c’è stato un momento nel tuo percorso letterario, in cui questa affermazione è stata pronunciata con orgoglio? Oppure ti sei trovata ad affermare con più disinvoltura:
“sono Valeria Parrella”?
Sono Valeria Parrella e sono una donna del sud che più sud non si può. E certo che c’è orgoglio nel dirlo, cosa altro? Però ti dico pure che se mi sento più vicina ai sud che ai nord, alla Grecia che all’Olanda, è anche vero che penso sempre che dove nasciamo è un caso, altrimenti non potrei capire profondamente le migrazioni e pensarle come una possibilità di rinascita, per chi parte e per chi accoglie.