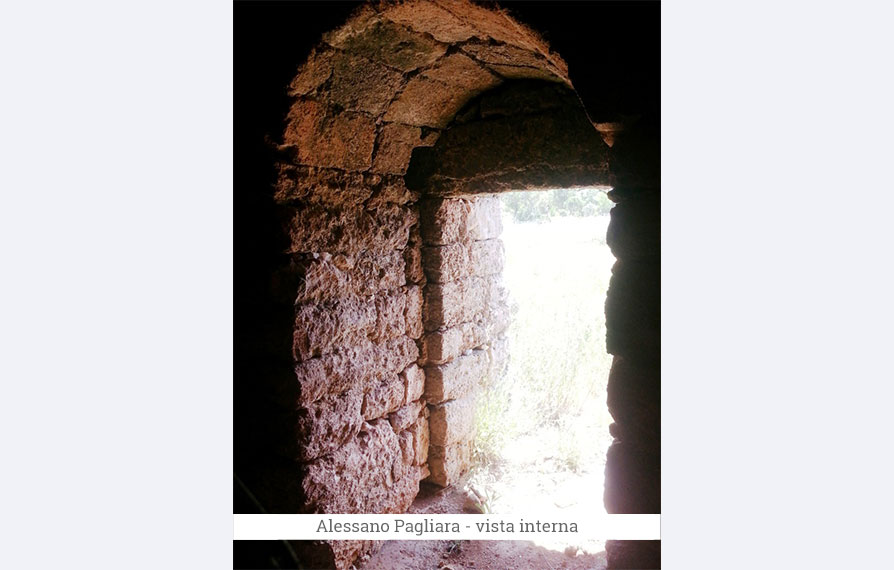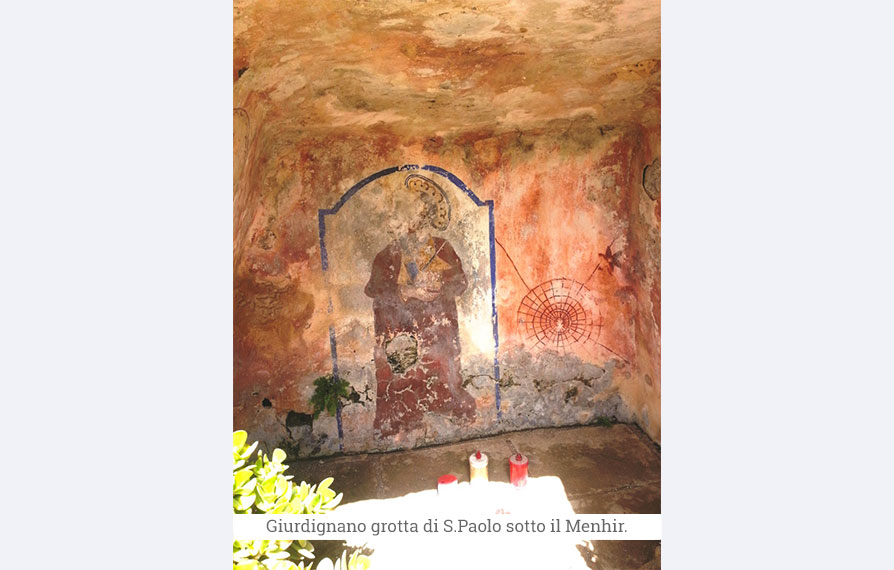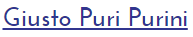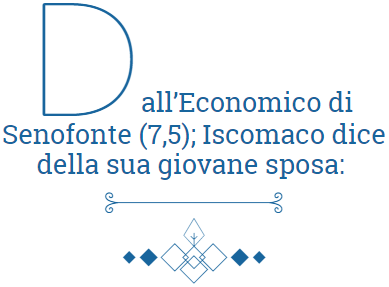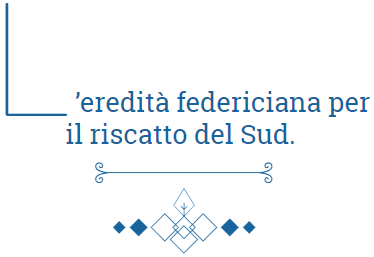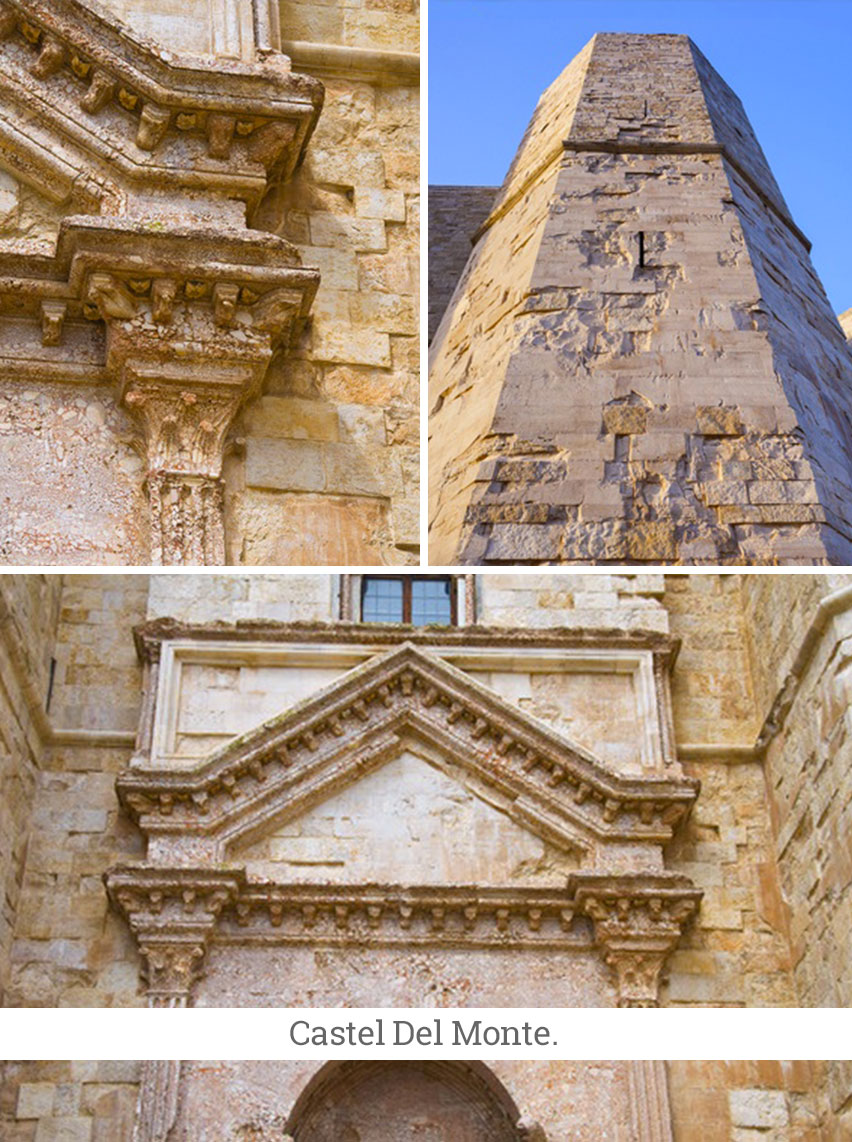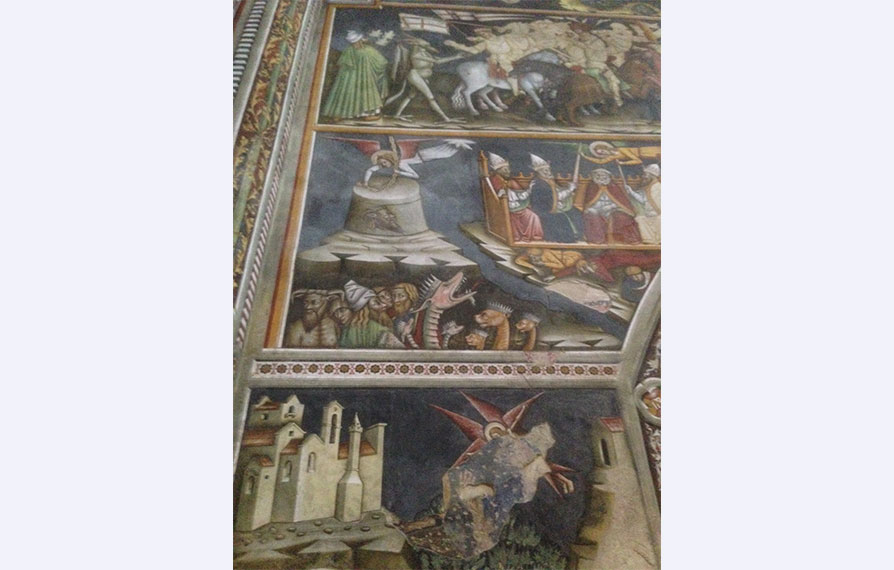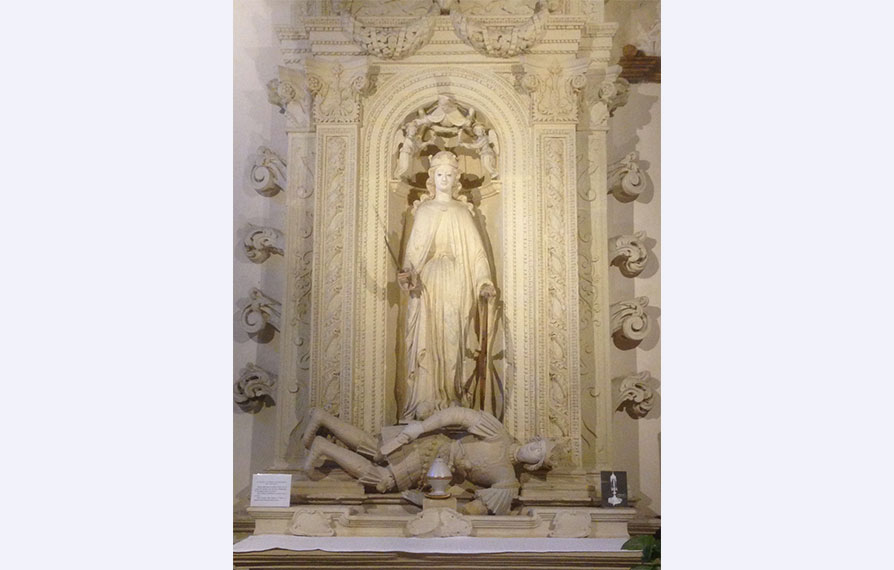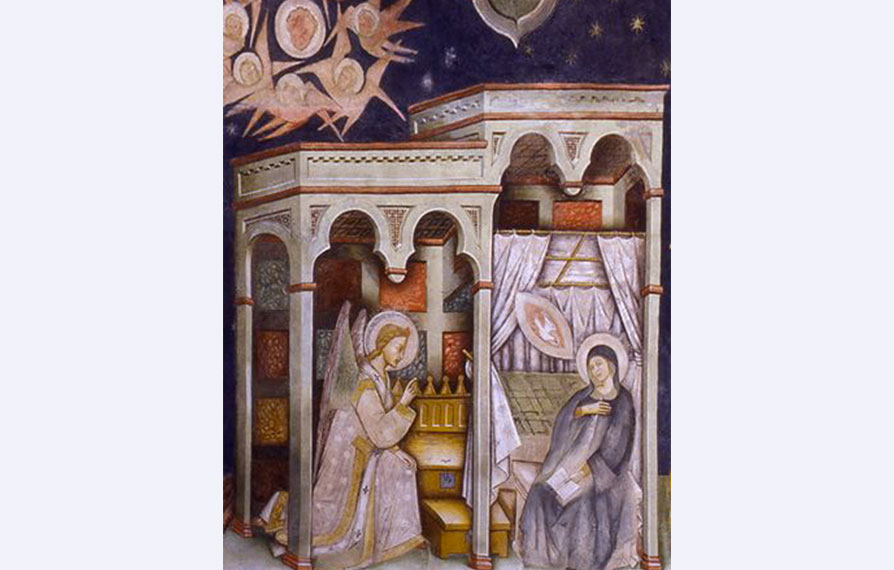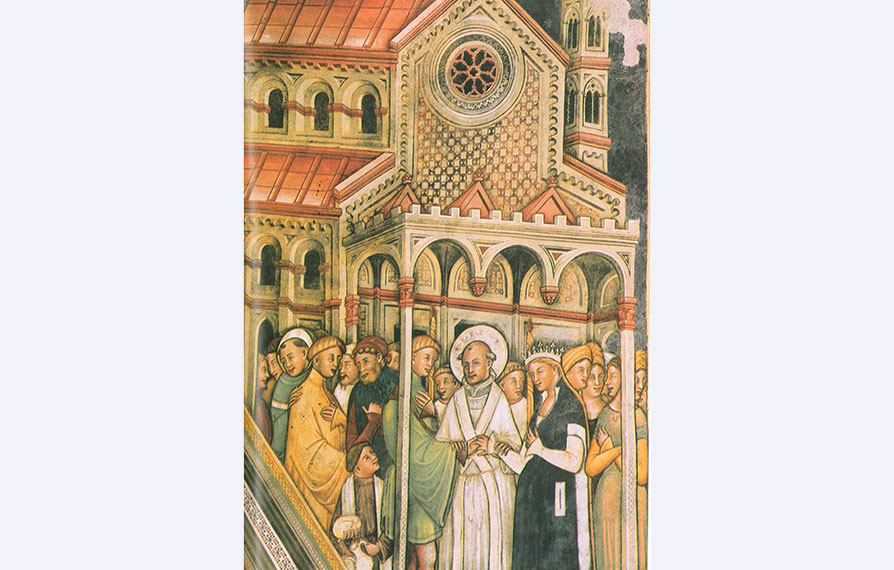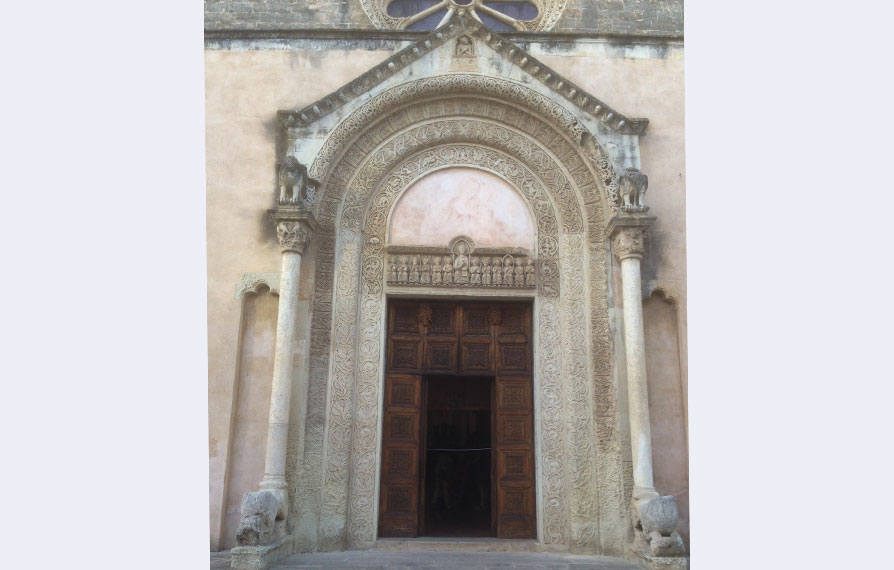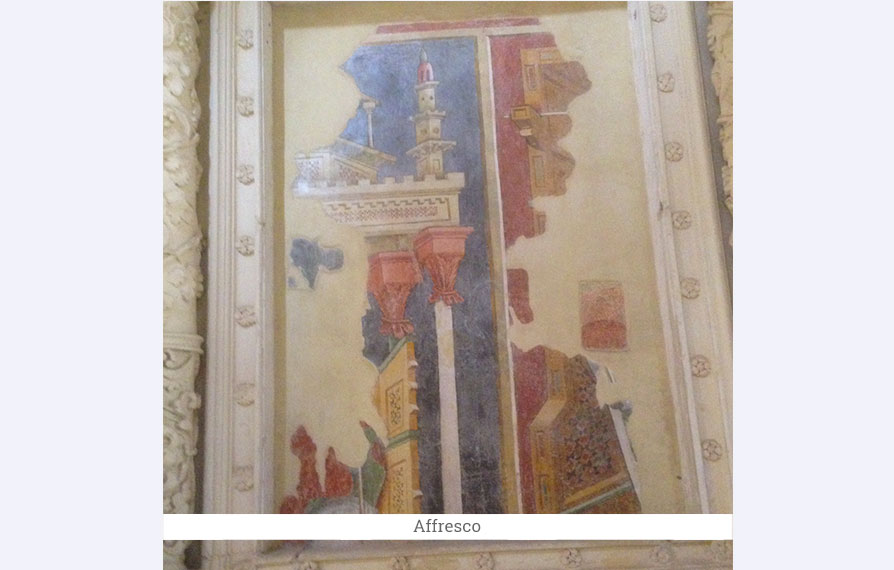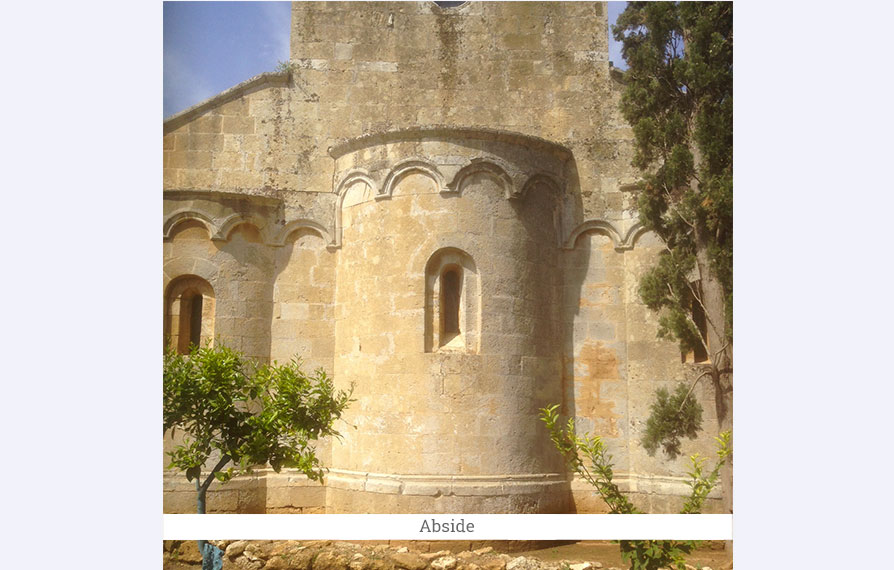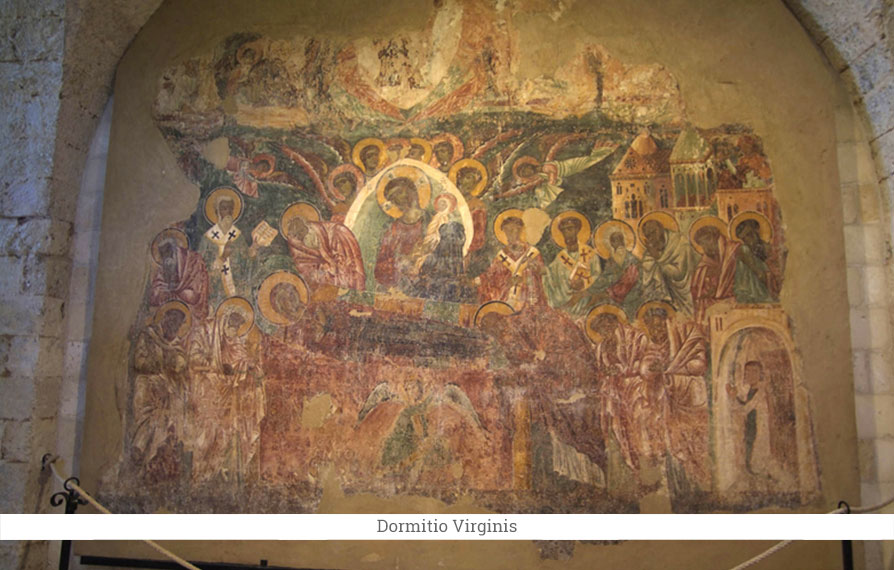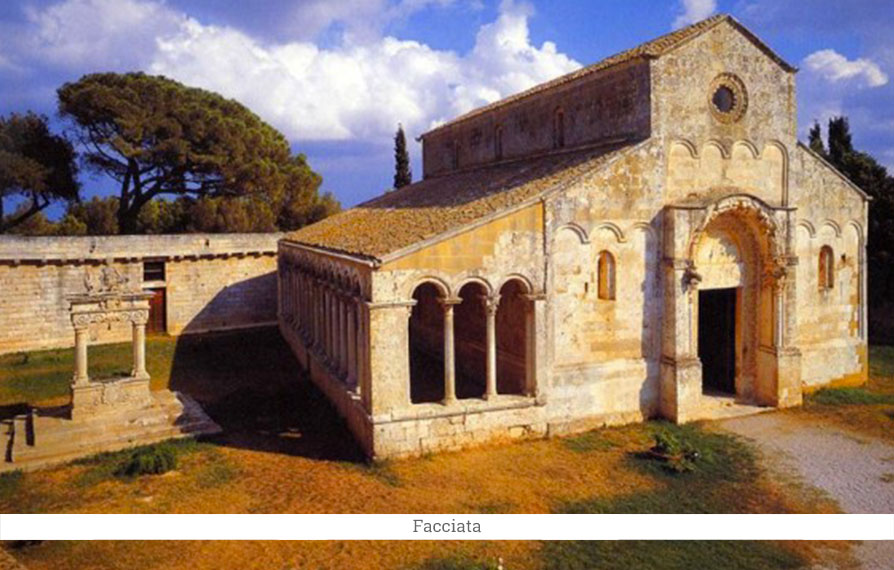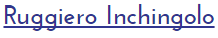Matteo de Augustinis è stato un figlio del profondo Cilento, nel quale è nato 207 anni fa, a Felitto, un anno dopo lo scoppio della rivoluzione francese, da una famiglia che fu fatta oggetto della più bieca reazione da parte delle marmaglie del Cardinale Ruffo.
La sua casa natale fu data alle fiamme, ed i suoi parenti costretti ad una terribile diaspora. Morì troppo presto, e nel luogo sbagliato (nel 1845 in quella Napoli, la cui classe colta era stata più che decimata con la restaurazione e chi che era sopravvissuto viveva nel sospetto e nel terrore), per essere incluso fin dall’inizio tra i padri della Patria.
MATTEO DE AUGUSTINIS, DIVULGATORE E MAESTRO



Incarcerato ben due volte perché di idee sovversive, Matteo de Augustinis era un giurista (avvocato), professore ed economista, incarnando un’idea consolidatasi nella tradizione partenopea: prima che economisti, bisognava essere giuristi, perché
L’abolizione del feudalesimo fu una grande svolta “epocale”, dovuta anche all’impegno di molti economisti, come Giuseppe Palmieri, che aveva scritto, tra l’altro, “Riflessioni sulla pubblica felicità relativamente al Regno di Napoli e altri scritti” (1788), in cui, per “pubblica felicità” si intendeva l’uscita del popolo dall’ignoranza e dall’oscurità verso la luce, secondo il più ortodosso illuminismo.
L’idea delle pubblica felicità è fondamentale nell’insegnamento di de Augustinis. Dal post-feudalesimo era derivato un complicato contenzioso che contrapponeva anche i proprietari latifondisti (baroni) alle città (università), in cui si riconoscevano le classi sociali borghesi ed operaie in formazione. Il tutto si svolgeva in uno Stato rigorosamente chiuso all’esterno, che faceva della politica dei dazi il suo centro propulsore economico. Vaghi accenni riformatori duravano poco e creavano delusioni (anche a de Augustinis).
il grande evento di quegli anni era stato l’adozione, per il Regno delle due Sicilie, della legge n. 130 del 2 agosto 1806, il cui primo articolo recitava: «La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita. Tutte le giurisdizioni sinora baronali, ed i proventi qualunque che vi siano stati annessi, sono reintegrati alla sovranità, dalla quale saranno inseparabili».
Il primo da ricordare è Antonio Genovesi (che era morto a Napoli nel 1796), il quale, nel teorizzare la necessità di far uscire l’uomo dallo stato di “oscurità”, è colui che, per primo, aveva compreso la decadenza culturale, materiale e spirituale del Regno di Napoli e, quindi, si era reso conto della necessità di intervenire, invitando le nuove generazioni ad approfondire lo studio dell’economia. All’Università di Napoli aveva insegnato economia politica, con un insegnamento istituito appositamente per lui, denominato “Cattedra di commercio e di meccanica”. Genovesi teneva sempre le sue lezioni in lingua italiana e questo costituì il modo per diffondere ad ampio spettro lo studio dell’economia e delle scienze tra sempre maggiori segmenti di popolazione. Matteo de Augustinis si innamorò subito dell’idea di raggiungere il maggior numero di persone con l’insegnamento.
Tra i suoi “economisti defunti” sono anche citati: Antonio SERRA (calabrese di nascita, ma morto a Napoli intorno al 1625), un’originale figura di genio meridionalista, che ha scritto, mentre era detenuto al carcere della Vicaria, l’introvabile “Breve trattato delle cause che possono far abbondare li regni d’oro e d’argento dove non sono miniere”, con applicazione al Regno di Napoli, esaltando l’importanza del mercato interno per un’economia troppo ripiegata su se stessa; Giovan Donato TURBOLO, (prima metà del 1600) un precursore del mercantilismo, esperto della politica monetaria del Regno di Napoli, da Ischitella; Francesco MENGOTTI, collaboratore di Cesare Beccaria, e ministro della Repubblica Cisalpina, che aveva analizzato l’economia di mercato, osteggiata dal protezionismo borbonico, alla luce del mercantilismo; Pietro VERRI (morto nel 1797), in qualche modo precursore di Adam Smith, perché, nelle Meditazioni sull’Economia Politica (1771), aveva enunciato (per primo in forma matematica) le leggi di domanda e offerta, aveva spiegato il ruolo della moneta quale “merce universale”, aveva appoggiato il libero scambio e sostenuto che l’equilibrio nella bilancia dei pagamenti è assicurato da aggiustamenti del prodotto interno lordo (quantità) e non del tasso di cambio (prezzo). Matteo de Augustinis rimase affascinato dall’idea che la libera concorrenza potesse servire a distribuire correttamente la proprietà privata. In questo si spiega la sua ammirazione, testimoniata nell’opera “Lettere” per Ferdinando GALIANI (educato a Napoli), che, nel 1751, aveva teorizzato nel trattato Della Moneta il valore economico dei beni, passando attraverso una relazione nientemeno che tra quantità e qualità del lavoro, tempi di produzione, utilità e rarità del prodotto. Dalla lettura di Sallustio BANDINI (morto nel 1760), senese e gesuita, esperto in diritto bancario (la cui statua è a Siena, davanti alla sede del Monte dei Paschi), de Augustinis apprezzò l’idea di porre il sistema bancario a servizio di tutte le classi sociali, avvalorata dal libro di Lodovico Ricci, storico ed economista, che aveva pubblicato il libro “Riforma de’ pii Istituti della Città di Modena”.
In questo contesto, bisognava creare, da una parte, una coscienza tra la gente per sradicare l’idea stessa di vassallaggio e, nello stesso tempo, creare e utilizzare sia le nuove risorse che si erano liberate sia nuove frontiere di occupazione e produzione per ideare e favorire le riforme sociali, politiche ed economiche:
era, cioè, necessario coniugare la scienza giuridica e quella economica, nell’ambito della quale era fondamentale anche il ruolo della neonata statistica, che affascinò molto de Augustinis. Leggendo la prefazione, curata dall’autore stesso, del volume “Elementi di economia sociale” pubblicato a Napoli nel 1842, si nota che la dedica è fatta “ai grandi economisti defunti”, citati con rispetto e devozione, nel preambolo del libro. A costoro fa dire: “Noi non morimmo, ma viviamo, tuttavia, colaggiù, siam vivi nelle nostre opere e nella memoria di coloro che tanto amammo”. De Augustinis collega, dunque, la propria opera agli economisti defunti che vivono “colaggiù” e, cioè, nell’impegno dei suoi contemporanei.
L’elenco che ne fa è lungo, ma ragionandoci sopra, è molto importante per capire da che parte stava.
La lettura della lista ha una sua logica e chiave interpretativa, che, senza mezzi termini, fa capire che Matteo de Augustinis si reputa una delle voci che intende saldare il nuovo al vecchio, assimilando e sviluppando la summa del pensiero della tradizione “colta napoletana”.
Da queste letture deriva a Matteo de Augustinis l’idea di ipotizzare un obbligo di investire nelle casse di risparmio, enunciata nel suo discorso sulla povertà degli Stati. In questo riecheggiano anche le idee di Cesare Beccaria.
Nell’ambito dei grandi defunti non poteva mancare Gaetano FILANGIERI, brillante esponente dei “nobili liberali” napoletani, quelli dai quali derivò la rivoluzione del ‘99. Altri grandi economisti cari al Nostro furono Melchiorre GIOIA, che, dopo la caduta di Napoleone, aveva prodotto le sue opere maggiori, come il “Nuovo prospetto delle scienze economiche” e, ancor più, “Sulle manifatture nazionali” (1819), la cui eco si sente nell’ultima fatica di Matteo de Augustinis “della Valle del Liri e delle sue industrie”, che sarà, poi, anche la relazione tenuta a Napoli nei giorni della sua morte (1845) in un convegno di economisti italiani. Il libro sulle manifatture di Gioia, peraltro, non era stato gradito al Governo borbonico: il volume fu messo all’indice e Gioia fu arrestato, nel 1820.
La stessa sorte, non foss’altro che per aver condiviso le tesi di Gioia, fu riservata a Matteo de Augustinis.
Da Carlo Antonio BROGGIA, autore di un Trattato de’ tributi, delle Monete, e del Governo politico della Sanità, de Augustinis trasse la logica del metodo nel gestire le risorse pubbliche in vista del loro uso sociale. Da Gian Domenico Romagnosi, de Augustinis derivò la convinzione che l’intera esperienza politico-sociale del XVIII secolo sia stata compresa, riassunta e condensata attraverso la fiducia nello sviluppo capitalistico e nella libera concorrenza economica, teorizzando che i poteri pubblici devono far rispettare le corrette regole della libertà di concorrenza. Di qui l’assoluta presunta centralità del pensiero di Romagnosi, secondo de Augustinis, nell’ambito del pensiero dell’800.
De Augustinis fu, in effetti, un acuto osservatore della realtà contadina ed industriale (come emerge nel discorso sulla Valle del Liri, di cui si è detto); non gradiva gli eccessi, ma si commuoveva davanti allo sfascio della sanità e della scuola della Napoli dell’epoca (pronunciò un accorato “discorso sulla povertà”).
Si lanciava in ardite proposte “globali”, pur conoscendo l’Europa solo attraverso i libri: e così commise anche errori, come il considerare l’Inghilterra bersaglio di molti strali, pur apprezzando Adam Smith, o come arrivare a negare l’aumento della miseria nel Regno; ma,
la sua logica, in genere, è sempre quella di trovare forme di mediazione fra tendenze diverse, esaltando le specificità della vita del Sud, del Tavoliere pugliese, del Cilento, del casertano, della Calabria etc., e ritenendo, comunque, che ogni teoria economica possa essere, almeno in parte, buona per la causa di consolidare l’uscita del popolo di Napoli e del Sud da una situazione di abiezione, e di rassegnazione,
vera origine della sua povertà, stimolandone l’azione, il lavoro, il commercio e, dunque, la via della “felicità” nei termini elaborati da Genovesi. De Augustinis manifesta la fiducia che la strada intrapresa dagli economisti “amici” sia indefettibilmente esatta.

Napoli, in realtà, a quell’epoca, era un centro di prima grandezza in Europa per tradizioni di influenza nei confronti delle istituzioni e del potere politico locale, consolidate e robuste nella cultura del diritto meridionale; ma era anche, diremmo oggi, in qualche modo terribilmente isolata ed autoreferenziale a seguito delle purghe post-1799.
Matteo de Augustinis resta vittima di questa situazione: il destino non gli concesse il tempo di collocarsi nell’Italia unificata.
La sua speculazione scientifica si concentrò sullo studio e l’analisi della realtà del Regno e della sua gente. E, in questo, fu davvero grande: lo stesso famoso VII Congresso degli scienziati italiani, tenutosi a Napoli nel 1845, puntò a dimostrare quanto i giuristi-economisti napoletani fossero assolutamente attenti ad incrementare la “felicità” essenzialmente del proprio popolo, con questo attirandosi ovvie ed autorevoli critiche (in particolare dalla Germania, che vedeva la miseria della gente).
Il tempo in qualche modo, fu, però, galantuomo, perché alcuni di quelli che si allontanarono da Napoli, come Pasquale Stanislao Mancini, allievo, al pari di Antonio Scialoja, di Matteo de Augustinis, contribuirono con la loro idea di mercato libero ed allargato alla formazione dell’ideologia risorgimentale ed ai fondamenti economici della nuova realtà, mentre, nella seconda metà dell’800, chi era rimasto, senza colpa, nella logica e nella storia della Napoli preunitaria ne fu soffocato dalla decadenza.
Forse questa conclusione potrebbe portare a capire come un’intelligenza eccezionale, interamente cresciuta e misurata sulla cultura e sulla gente del meridione, ha pagato il suo amore verso il Sud con l’emarginazione, dovuta alla diffidenza della grande tradizione economica continentale, pur potendo dire di aver contribuito seriamente al meglio della tradizione socio-economica italiana post-unitaria.