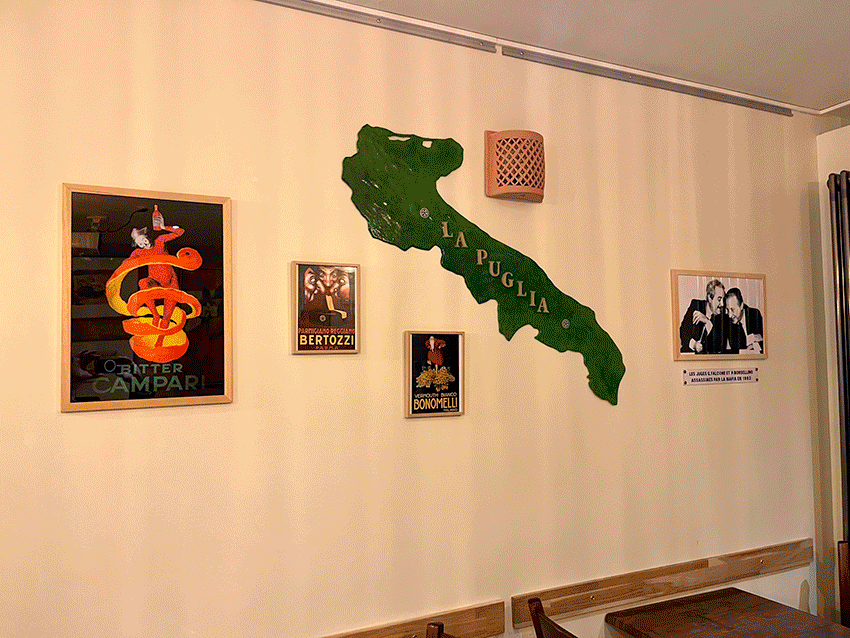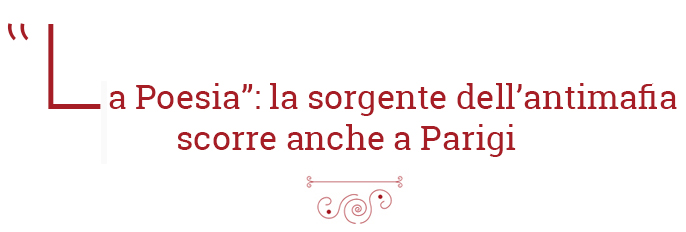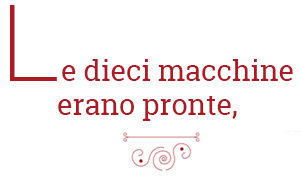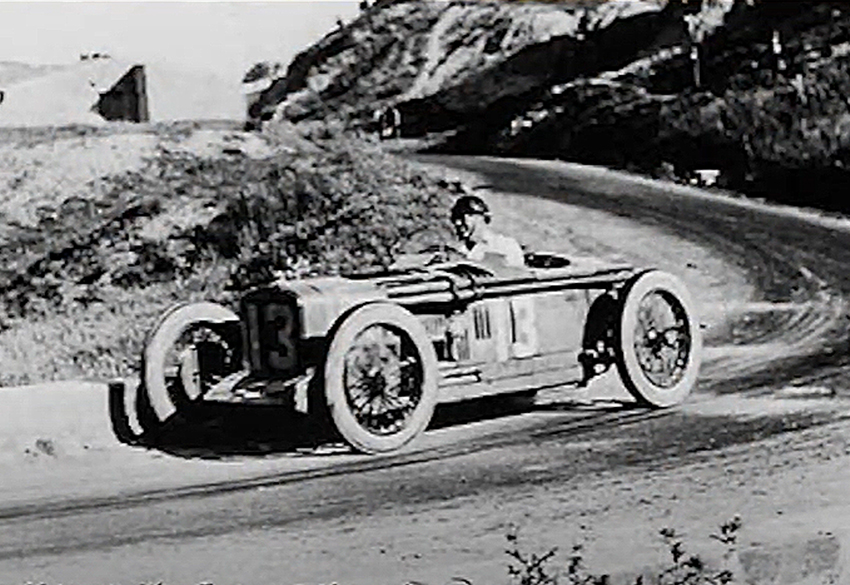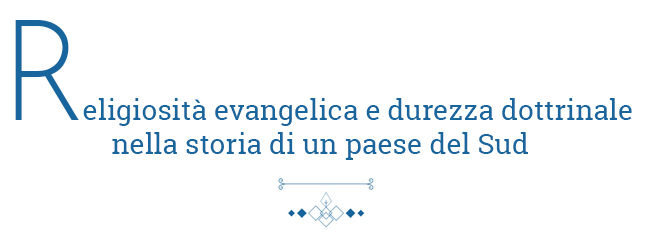SUD ITALIA ATTRAVERSO IL MEDITERRANEO

Val di Noto e gastronomia è un’associazione che viene naturale. La capacità di valorizzare pienamente, e spesso in maniera sorprendente, i magnifici prodotti del territorio ha reso questo scorcio di Sicilia una delle aree più interessanti da esplorare sotto il profilo culinario. In questa cornice si colloca una delle eccellenze della cucina del Val di Noto: il gelato.
Cresciuto proprio in una cultura in cui le discussioni estive sul gelato possono protrarsi fino a tarda notte e creare tensioni non da poco su aspetti cruciali del prodotto (quale deve essere il colore del gelato al pistacchio? Funziona l’abbinamento cioccolato-limone? Il gelato di ricotta ha un suo perché?), ogni volta che ho affrontato una nuova esperienza all’estero sono andato sempre a scoprire le realtà locali del gelato. Per essere chiari, mai cercata la replica dei sapori siciliani, sarebbe un’ottica errata e perdente. Al contrario, l’obiettivo è stato quello di esplorare e sperimentare nuovi gusti e combinazioni, dal gelato viola di taro, al gusto di fagioli rossi, al gelato di riso, immancabile in Asia.
Ma talvolta, oltre i gusti, le combinazioni e le tecniche che vengono utilizzate,
sono le storie delle gelaterie che diventano altrettanto gustose.
E da qui parte la breve storia della gelateria “Ragusa” a Jakarta,
aperta negli anni ’30 dello scorso secolo.
Storia dai contorni non chiari, contraddittori, avvolta da una nebbiolina che non permette di mettere a fuoco tutti i dettagli, dunque perfettamente in linea con le caratteristiche dell’Indonesia ed in particolare di Java. Nella continua scoperta di storie, cibi, persone e culture che popolano questo meraviglioso Paese, mi sono imbattuto quasi subito nella gelateria “Ragusa”, che naturalmente ha attirato la mia curiosità.
Le informazioni raccolte durante e dopo la mia permanenza in Indonesia non sono state univoche: dal nome, che secondo alcuni indica il luogo di provenienza dei proprietari originari della gelateria e secondo invece la versione che ha riscontri più concreti il cognome degli stessi, al motivo stesso per cui i nostri connazionali si trovassero a Jakarta negli anni ’30.
La versione che presenta elementi riscontrabili in maniera più solida, anche grazie
al materiale raccolto dal nostro Console Onorario a Bali, è che i fratelli Ragusa provenissero da Grottaglie in Puglia e che fossero arrivati a Batavia
(il nome che aveva l’attuale Jakarta durante il periodo coloniale olandese)
alla fine degli anni ’20.
Qui i contorni della storia iniziano a diventare meno chiari e netti: sembra che i Ragusa, di professione sarti, stessero viaggiando in nave per l’Australia e fossero stati convinti a fare una sosta a Batavia da alcuni passeggeri a bordo della loro imbarcazione. Alcune testimonianze invece asseriscono che i Ragusa fossero arrivati a Batavia per frequentare una scuola di cucito, una tesi che appare ardita e poco verosimile: perché da Grottaglie negli anni ’20 ci si sarebbe dovuti dirigere a Batavia per imparare il cucito o altre arti sartoriali?
All’interno della gelateria si trovano invero le foto dei quattro fratelli Ragusa, Luigi, Vincenzo, Pasquale e Francesco, foto color seppia che aggiungono autenticità alla narrazione prevalente. Stando a quanto si tramanda, Luigi e Vincenzo erano venuti in contatto con una signora olandese residente a Bandung proprietaria di una fattoria, disposta a fornire il latte per la nuova avventura commerciale dei Ragusa. La tesi che fossero pugliesi viene ulteriormente avvalorata dal fatto che i fratelli Ragusa lasciarono l’Indonesia nel 1972 e si stabilirono a Taranto. La gelateria venne ereditata dal cognato di Francesco, che si era sposato con Liliana Yo, una cinese indonesiana.
Riconosciuta nel 2012 come la più antica gelateria in Indonesia ancora in attività,
ha avuto nei decenni alterne fortune ed ha anche offerto prodotti che sono cambiati nel tempo, dai gusti tradizionali fino ad arrivare al gelato agli spaghetti, ottenuti dalla polpa del cocco.
In conclusione,
l’arrivo e la permanenza di una famiglia di sarti pugliesi in Indonesia ha lasciato un’impronta duratura nel panorama gastronomico di Jakarta,
visto che ancora oggi la gelateria “Ragusa”
è attiva ed operante.
Questa vicenda mi ha affascinato da sempre, perché trovare storie di italiani nei paesi con una forte presenza di nostre comunità è semplice, ma lo è meno trovarle in Indonesia, dove la nostra presenza è stata storicamente sporadica. Anche se, in verità, in Indonesia è morto Nino Bixio e Pigafetta ha fatto tappa con la nave Trinidad nella spedizione della circumnavigazione del globo nella quale rimase ucciso Magellano, senza dimenticare, inoltre, le missionarie e i missionari italiani (il primo sinologo europeo è stato padre Ruggeri, pugliese di Spinazzola), gli esploratori e gli etnologi ed etnologi come Modigliani.
Sono storie quelle degli italiani nell’Asia orientale e sud-orientale, molti dei quali provenienti dal Meridione, che meritano di essere meglio conosciute,
perché testimoniano del coraggio e dell’intraprendenza
di molti nostri connazionali
a costruirsi il proprio futuro anche in terre lontane e nelle quali non erano già presenti comunità di compatrioti. E mi piace pensare che il grande successo dello stile di vita italiano, del made in Italy e dell’Italia in generale in questa parte di mondo sia anche dovuto a quanto seminato dai vari fratelli Ragusa che vi hanno abitato.