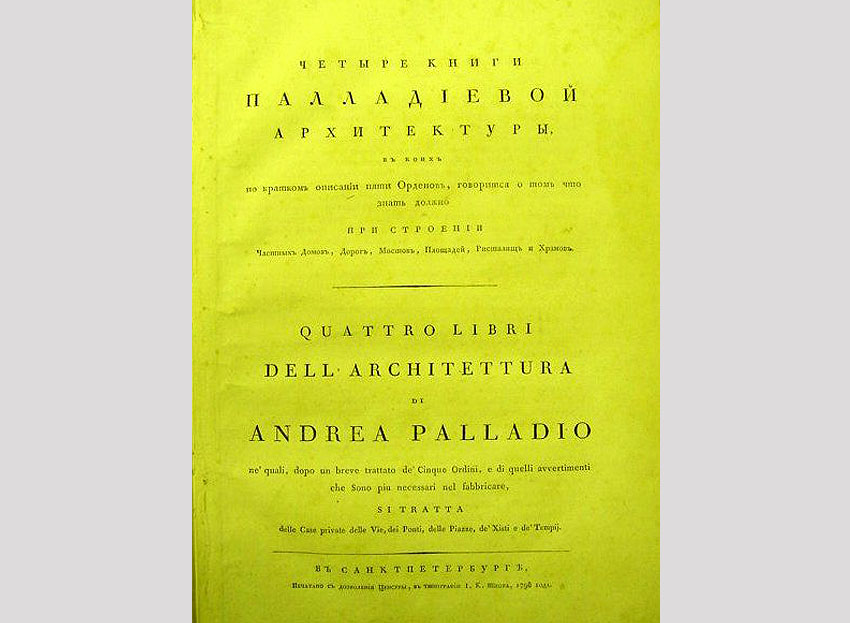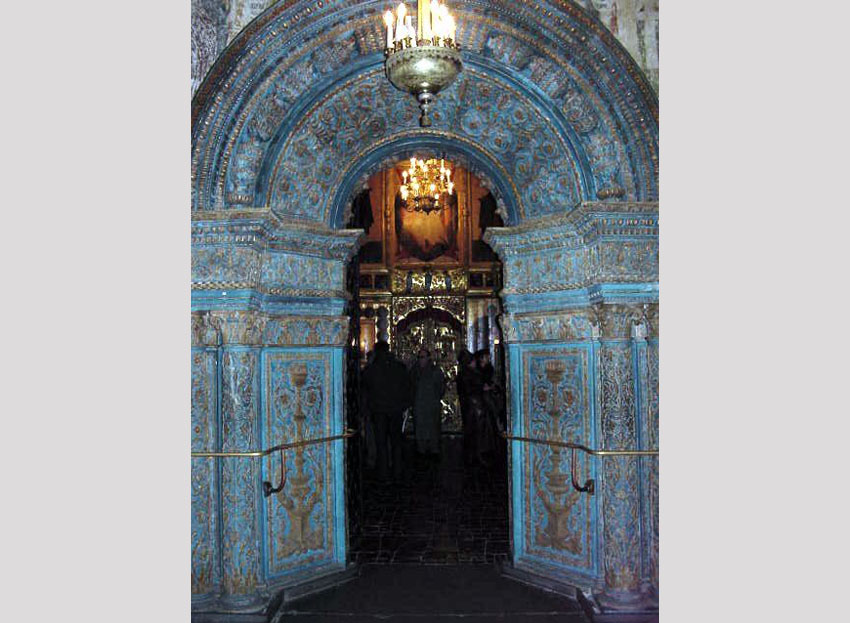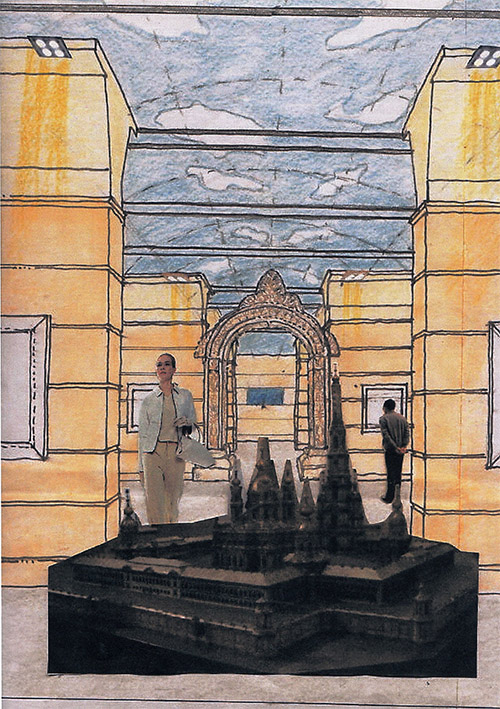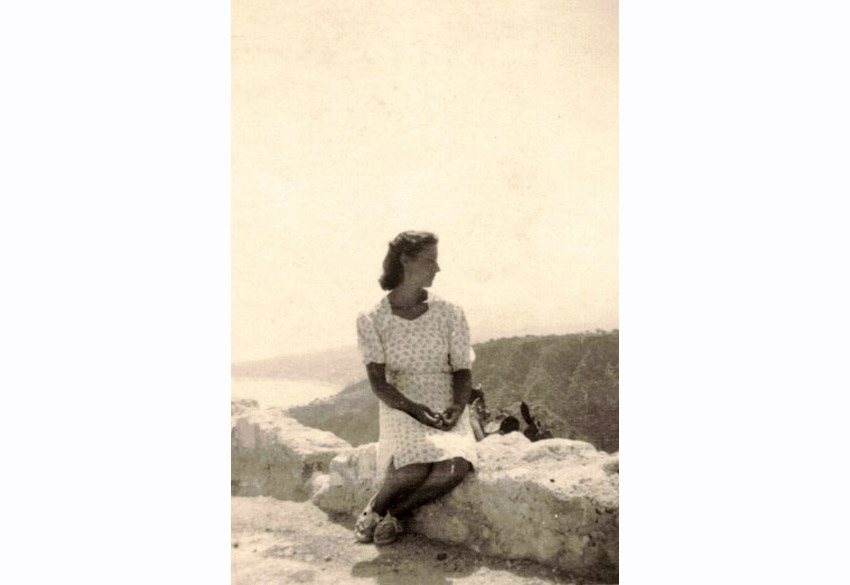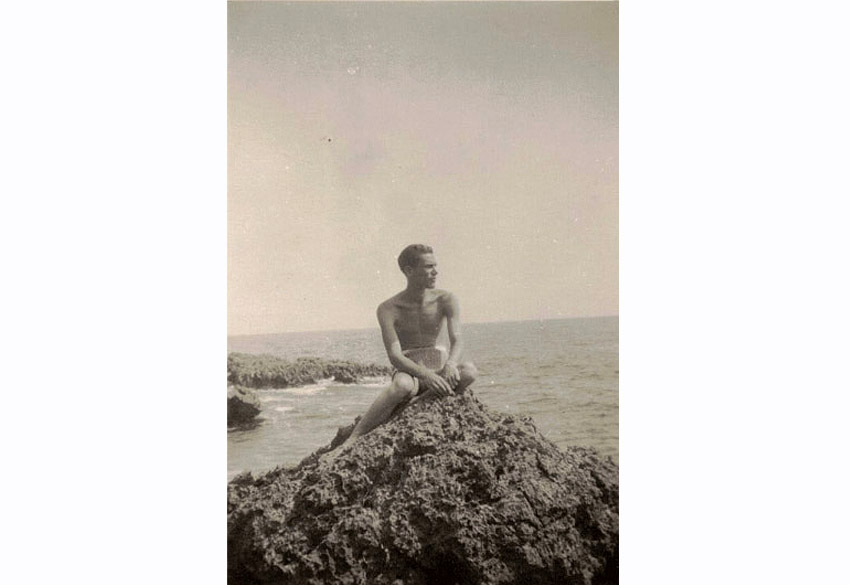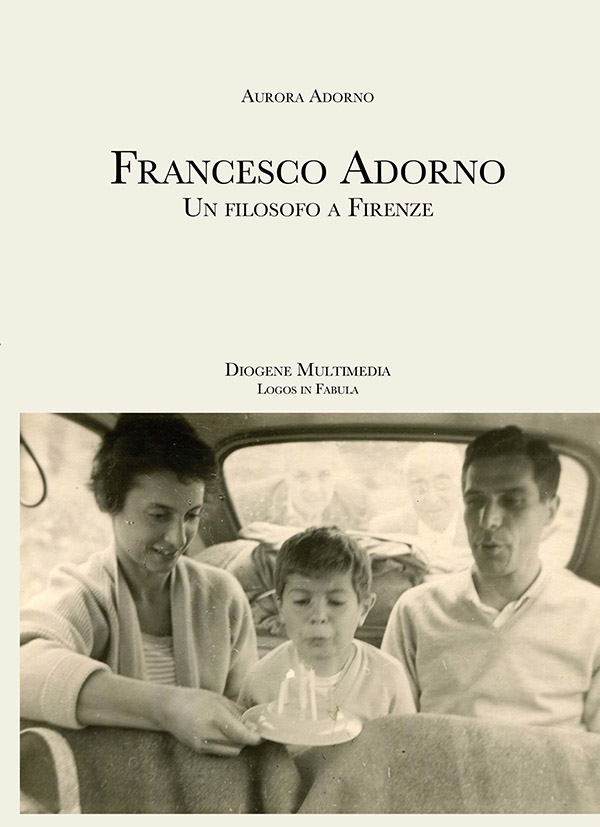C’ERA UNA VOLTA IL SUD
Accendere il televisore e accorgersi che, dall’arcipelago delle banalità colorate, spunta fuori un florilegio di informazioni intriganti e inconsuete. Accade anche questo nella pigra stagione del covid-19, grazie ad un’azzeccata puntata di “Frontiere”, programma di inchieste di Rai1, brillantemente condotto da Franco Di Mare. Il telespettatore, colto a boccheggiare tra ansie di nuovi contagi e promesse di rimedi miracolosi, viene raggiunto da alcune rivelazioni sorprendenti:
“Napoli è diventata la città dove si legge di più in Italia e, dalla città di Eduardo,
si irradia nuovamente un messaggio culturale vincente
che raggiunge il mondo intero”. Lo sapevate?
Francamente io no. Vedremo tra qualche riga il perché. Attenzione, però, Napoli non è sola, nel nuovo quadro, affrescato senza pregiudizi, che dipinge il nostro Meridione senza farlo annegare nell’oceano profondo degli stereotipi criminali.
A Napoli, nella nuova narrazione letteraria e televisiva, fa buona compagnia un nutrito drappello di città e di paesaggi, geografici ed umani. Una “Terronia” finalmente colta nella sua interezza e non esclusivamente negli aspetti sociali più deteriori e logori. In testa c’è, comprensibilmente, la luminescente e onirica Vigata, dipinta attraverso pagine e immagini che hanno come protagonista Salvo Montalbano, il famoso personaggio nato dalla penna di Camilleri, ma questa non è una novità.
Ci sono, in questo quadro, altri spicchi di Campania, di Sicilia,
angoli e atmosfere attraenti e originali della Puglia, della Basilicata.
Tutti raccontaticon uno sguardo prospettico, ampio e finalmente non strabico
Un assembramento e una rappresentazione inimmaginabili fino a qualche anno fa. Da questi personaggi e paesaggi del nostro Mezzogiorno, dipinti con colori plurimi, viene fuori un affresco meridionale, un mosaico umano e culturale che cozza frontalmente con lo stereotipo del Sud imbarazzante zavorra d’Italia e palla al piede di un Nord avanzato e più progredito. Un paesaggio materiale e immateriale che “scalda i cuori” e affascina mezzo mondo.
Esordisce con questa lettura Franco Di Mare, colto giornalista e volto noto della Rai. Le immagini iniziali sono un serrato succedersi di dialoghi tratti da “L’amica geniale”, la fiction tv ricavata dai best seller internazionali di Elena Ferrante, la scrittrice di cui non è stata ancora svelata la vera identità e in qualche misura “non c’è”, proprio come non c’è il paese immaginario di Vigata.
Invenzioni letterarie e televisive che non solo non nuocciono, ma attraggono
ed esaltano l’immaginazione di lettori e telespettatori, con traduzioni televisive
dei successi letterari che amplificano il richiamo delle opere originali e viceversa.
L’idea, anch’essa geniale, partorita dalla mente di Di Mare, uomo del Sud dalla vocazione cosmopolita, ma che non ha mai ripudiato le proprie radici napoletane, è stata quella di cucire insieme diverse fiction televisive di successo straripante, alcune anche al di fuori dei ristretti confini nazionali, e accorgersi che sono tutte Made in Sud, elaborate, dirette o interpretate, quasi sempre, da autori, protagonisti ed attori meridionali.
Il “Montalbano” con il volto di Luca Zingaretti, venduto in 65 Paesi del mondo, “L’amica geniale”, trasposizione televisiva di una quadrilogia letteraria esaltata dal New York Times, “Un posto al Sole”, fiction ormai giunta al traguardo storico del suo venticinquesimo anno di vita, “I Bastardi di Pizzofalcone”, dal toponimo di una delle zone più popolari di Napoli che festeggia la partenza della sua terza serie, “Imma Tatangelo”, magistrato grintoso che si muove con disinvoltura tra le trame insolite e le suggestioni arcaiche dei Sassi di Matera, assurti ormai alla ribalta mondiale grazie alle celebrazioni per la capitale europea della cultura nel 2019.
A noi, qui, non interessa molto descrivere gli espedienti narrativi che hanno decretato il successo di queste produzioni televisive. Più interessante, invece, è
seguire le motivazioni di questa sorprendente capacità di attrazione di una vasta regione geografica e di un modello umano, sociale e culturale, che, fino a ieri,
si ritenevano arretrati e penalizzanti per il resto del Paese,
quello considerato più creativo, dinamico e saldamente agganciato al treno produttivo dell’Europa continentale e dell’Occidente industrializzato. Ricordando il Goethe di “Viaggio in Italia”, là dove l’autore descrive il Meridione e le sue genti con spirito quasi folgorato da un transfert che lo fa sentire meridionale tra i meridionali, alcuni personaggi intervistati nel corso della trasmissione danno una loro interpretazione originale e anticonformista dell’irresistibile fascino del Sud. A cominciare dall’idea che Napoli possa mantenere un forte potere di attrazione anche lontano dalla luce abbagliante del suo mare da cartolina, dall’immagine ricorrente del Vesuvio sormontata da un nebuloso pennacchio, dai suoi personaggi plebei più abusati. Come è possibile? Entrando e conoscendo meglio, ad esempio, le figure umane che animano, nel bene e nel male, quel “verminaio” dei suoi vicoli più stretti, come scrisse Dickens.
Napoli capitale dell’immaginario. Napoli centro dell’attenzione. Lo afferma Alessandro Gassman, protagonista de “I Bastardi di Pizzofalcone”. ”Napoli tira fuori il meglio di se stessa proprio nei momenti di maggiore di difficoltà”, sostiene l’attore.
Città cinematografica per eccellenza afferma lo scrittore e sceneggiatore
Maurizio de Giovanni, al di sopra degli stereotipi, tutti tragicamente veri
e altrettanto realisticamente falsi se indagati nella realtà antropologica
dei vicoli della Città. Napoli inclassificabile e sospesa
tra condanna e assoluzione.
L’autore di “Terronismo”, lo scrittore Marco de Marco, osserva acutamente che il pessimismo cupo di “Gomorra”, a volte, infastidisce perché viene interpretato come un vicolo cieco, una chiave unica e immutabile di lettura della realtà degradata delle periferie napoletane. Altre città occidentali si caratterizzano per aspetti di criminalità esasperata, maggiore di quella che si riscontra a Napoli, però vengono dipinte con un ventaglio di rappresentazioni che dal nero della violenza passano al rosso delle passioni sensuali al rosa tenue dei sentimenti più delicati. Modello esemplare New York, città violenta, ma che letteratura e cinema descrivono anche nei suoi aspetti più accattivanti, quelli brillanti di Woody Allen, quelli frizzanti di “Colazione da Tiffany”.
Un approccio poliedrico al Sud consente una maggiore aderenza alla realtà
in fieri, non al cliché stanco di narrazioni in bilico
tra lo strapaese e la lupara.
Il successo de “I Bastardi di Pizzofalcone” dipende forse anche dal fatto che la serie tenta di raccontare una Napoli dove c’è tutto, anche una città normale, una borghesia civile, che sa e vuole reagire alla criminalità. “Raccontiamo Napoli nella sua interezza, aspetti meravigliosi e angoli spaventosi”, sostiene con convinzione Alessandro Gassman. Alla luce di questa nuova e condivisa chiave di lettura condivisa appare distante il Meridione de “La piovra” e sfocata la lettura, senza redenzione, della già citata “Gomorra”. Di tutti gli intervistati è la convinzione che la forza con cui il Sud sviluppa, alla lunga, la sua prorompente forza di attrazione nasca dalla consapevolezza che, la violenza, la mafia, le brutture del Meridione, pur non venendo minimamente assolte, vengono sempre, comunque, riassorbite dal respiro più vasto del suo paesaggio incantato, dalle tante bellezze artistiche che caratterizzano questa metà meno opulenta dello Stivale, ed anche dai sani valori di fondo della maggior parte della popolazione, dal manifesto calore umano mostrato ai visitatori che intraprendono, per ragioni varie, un viaggio nelle regioni del Sud.
Dal florilegio delle loro osservazioni emergono descrizioni icastiche
di città, villaggi, paesaggi e personaggi letti con maggiore apertura mentale
e volontà di affermare un diverso codice di comunicazione
del messaggio visivo e concettuale.
Napoli è un’anguilla, non la spieghi e non l’afferri da nessuna parte, afferma un ospite. È vero, gli risponde qualcuno, può esser dolce e crudele pur restando se stessa. Napoli, infatti, non ha molti paragoni, a cominciare dal fatto che è una delle poche città in Europa, che ha visto crescere la sua periferia e il suo proletariato all’interno del suo ventre, non fuori della città, ma esattamente nel suo centro storico. Quei vicoli possono essere raccontati anche a prescindere dai suoi giovani e meno giovani residenti vocati alla piccola o grande criminalità.
Il successo della quadrilogia di Elena Ferrante, ora favorita anche dall’affermazione della fiction, è plateale, dieci milioni le copie finora vendute nel mondo.
Per Time la Ferrante è tra le cento personalità più influenti al mondo,
e “L’amica geniale” viene paragonata al romanzo ottocentesco “Piccole donne”, di Louisa May Alcott. Il sociologo Luigi Caramiello sostiene che la tessitura della trama, insieme con i suoi personaggi, recupera la memoria appannata del grande romanzo d’appendice, soprattutto nel raccontare il progetto di riscatto della povera gente, un riscatto che a volte può avere successo e altre no. Si può comunque affermare che si tratta del tentativo, riuscito, di dipingere un affresco composito dell’Identità italiana, almeno come la si intende nel mondo. E anche se questa identità enfatizzata mostra ancora il fianco allo scadimento nel folklore, un po’ come quando noi ci attendiamo di trovare tutti vestiti da cow boy con i cappelloni nel Texas e un traffico congestionato di dromedari in Tunisia, resta il fatto che
siamo di fronte ad una unicità del paesaggio del Sud, un modello
di rappresentazione non facilmente replicabile
in altre realtà, in Italia e nel mondo.
Vittorio Feltri, anche lui ospite della trasmissione in qualità di rappresentante di un Nord ricco e fatalmente escluso da questa rappresentazione, si dichiara fan di Montalbano, dice che è giusto che il Sud sia protagonista di questa realtà sfaccettata e complessa perché offre diversi e interessanti spunti di analisi e di riflessione, poi però si imbufalisce quando accusa la Rai di ignorare ingiustamente il Nord nelle sue più recenti serie televisive. Pochi romanzi, poca tv parlano oggi di Milano, nonostante il fatto che a Milano continuino a recarsi molti giovani per trovare lavoro. L’attrazione del Nord però non è più così scontata e neppure sempre vincente è la sua immagine. Forse perché è cresciuta una vigorosa comunità di scrittori meridionali. Napoli è la città più raccontata perché cinquanta e più scrittori sono nati o lavorano in questa città e risultano regolarmente iscritti alla Siae, la società italiana di autori ed editori. “Chi non legge a 70 anni ha vissuto una sola vita’”, ci ricorda Di Mare citando Umberto Eco, “Chi legge ha vissuto con Abele e Caino, con Dante, con I promessi Sposi”.
Vanessa Scalera, madre letteraria del personaggio di Imma Tatarani, ci conferma che la differenza fondamentale tra i vecchi e i nuovi personaggi delle storie del Sud risiede nel fatto che essi non sono più dipinti come macchiette, non sono tutti “sole e mandolino”, sono anche altro, però senza gettare alle ortiche il meglio delle proprie tradizioni.
La forza del Sud sospesa tra passato e presente. Un Sud proiettato in un futuro animato soprattutto dai giovani, imprenditori, professionisti, ricercatori,
che anche quando sono costretti all’emigrazione si sforzano
di mantenere vivi i tradizionali valori umani e familiari.
Ecco perché le rappresentazioni letterarie e televisive di questa realtà accendono il desiderio di visitare i luoghi dimenticati del Meridione, a cominciare da Matera, divisa tra i suoi spazi luminosi ed i suoi angoli grigi, quelli dei Sassi, non sempre inondati a profusione dal sole mediterraneo, una realtà sconosciuta ai più fino a tempi recentissimi. Che dire dei consolidati flussi di turismo a Porto Empedocle originati dal successo ventennale dei libri di Camilleri e, soprattutto, della serie televisiva ad essi collegata? “Quel pessimismo velato di ironia di Camilleri – dice Luca Zingaretti – è il sigillo autentico e riconoscibile del personaggio, il segreto della sua longevità. Montalbano ti trasmette la sua particolare visione della vita e il suo legame per il territorio, perciò il suo personaggio riesce agevolmente a viaggiare in tutto il mondo”.
Ora un’altra avventura televisiva sembra in corsa per consolidare un’idea di Meridione diversa e distante dai luoghi comuni: ”Vivi e lascia vivere”, con Elena Sofia Ricci, donna con unghie affilate, anch’essa immersa nella moderna realtà napoletana. Vedremo se ci regalerà un altro profilo ben tratteggiato di quel nuovo Sud che sembra emergere dal pentolone colmo di speranze che bolle sul fuoco del Terzo Millennio. C’era una volta il vecchio Sud, il nuovo lo stiamo tutti riscrivendo.