GENTE MOLTO PER BENE. JOHN FANTE E L’ABRUZZO
Per John Fante, italoamericano di seconda generazione, nato in America e che non sapeva parlare italiano, conoscendo solo qualche parola di dialetto ascoltata in casa, l’Abruzzo è puro mito. La terra primitiva dove è nato il padre, Nicola Fante, muratore che per sfuggire al freddo e alla miseria della sua terra, ha attraversato l’oceano, migrante economico, per lasciare le montagne appenniniche e raggiungere quelle così simili del Colorado.
È da qui, da questo padre e da questi ricordi, che tutto il lavoro letterario
di John Fante prende le prime mosse.
Già nell’incipit del suo primo romanzo pubblicato (Aspetta primavera, Bandini), prima ancora di Arturo Bandini, suo alter ego e ritratto dell’artista da giovane, compare il personaggio di Svevo Bandini, padre di Arturo:
“Avanzava, scalciando la neve profonda. Era un uomo disgustoso. Si chiamava Svevo Bandini (…). Detestava la neve. Faceva il muratore e la neve gelava la calce tra i mattoni che posava (…). Anche da ragazzo, in Italia, in Abruzzo, detestava la neve. Niente sole, niente lavoro. Adesso viveva in America, nella città di Rocklin, Colorado. (…). Le montagne c’erano anche in Italia, simili a bianchi monti a pochi chilometri di distanza verso occidente. Le montagne erano un gigantesco abito bianco caduto come piombo sulla terra.”1
E ancora più avanti, nello stesso romanzo, l’Abruzzo diventa l’argomento di un divertente e divertito dialogo tra Svevo e una ricca e colta vedova americana:
“E così lui era italiano. Splendido. (…). Doveva sentirsi orgoglioso delle sue origini. Non sapeva anche lui che la culla della civiltà occidentale era proprio l’Italia? Aveva mai visto la cattedrale di San Pietro, gli affreschi di Michelangelo, l’azzurro del Mediterraneo. E la Riviera? No, non li aveva mai visti. Le disse con parole semplici che era abruzzese, e non si era mai spinto a nord, nemmeno a Roma. Aveva lavorato duro, fin da ragazzo. Non aveva avuto tempo per nient’altro. L’Abruzzo! La vedova sapeva tutto. Ma allora aveva sicuramente letto le opere di d’Annunzio, era abruzzese anche lui. No, non l’aveva letto, quel d’Annunzio. Ne aveva sentito parlare, ma non l’aveva mai letto. Sì, sapeva che quell’uomo importante era della sua provincia. La cosa gli faceva piacere, sentiva gratitudine per d’Annunzio. Finalmente aveva trovato un terreno comune, ma con suo grande sconforto s’accorse di non avere nient’altro da dire sull’argomento.”
Ma l’Abruzzo di John Fante è soprattutto un piccolo paese,
Torricella Peligna, quel paese che, ci ha insegnato Cesare Pavese,
“ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via”.
Un paese che, per quanto lontano e mai visitato realmente, per John Fante è la garanzia di radici, di gente che a prescindere dal tuo ritorno, è rimasta ad aspettarti, come effettivamente è stato. Torricella Peligna è un luogo primordiale, l’Eden della sua mitologia familiare. Un mondo-paese popolato da personaggi leggendari come il suo antenato brigante Mingo di cui proprio il padre lo esorta a scriverne la storia nel romanzo Full of Life:
“Un uomo coraggioso, mio zio Mingo. Era un Andrilli, fratello di tua nonna. L’hanno appeso proprio là, in Abruzzo. I Carabinieri… Due proiettili nella spalla. Ma l’hanno appeso lo stesso. E sua moglie lì, che piangeva. Sessantuno anni fa. L’ho visto con i miei occhi. Coletta Andrilli, bella donna.”2
Ma l’Abruzzo è anche un ingombro di cui sbarazzarsi. Su John Fante infatti
c’è tutto il peso del pregiudizio razziale nei confronti degli italiani.
I dago, mangia-spaghetti, selvaggi ubriaconi, violentatori e assassini, mafiosi, sporchi come maiali. È un tema caro a Fante soprattutto trattato nella sua raccolta di racconti Dogo red. Il successo letterario vagheggiato da Arturo Bandini serve anche a questo: è la chiave di quel riscatto sociale per sconfiggere il pregiudizio che su di lui incombe in quanto italiano.
Per l’Abruzzo, John Fante è un nipote smarrito, un figliol prodigo letterario
mai tornato, ma che ha reso immortale e conosciuta in tutto il mondo
la piccola comunità di Torricella Peligna (nel Sangro Aventino,
in provincia di Chieti) che ormai da più di dieci anni
lo celebra in un festival3 a lui dedicato.
John Fante non è mai tornato nel paese del padre, proprio per paura di infrangere la sua natura mitologica. Ma sono tornati lì i suoi figli, soprattutto il poeta e scrittore Dan Fante, venuto a mancare da qualche anno, proprio per essere protagonisti di questa celebrazione annuale che ha portato lì scrittori, registi e musicisti di fama mondiale (Sandro Veronesi, Romana Petri, Ryan Gattis, Paolo Virzì, Frank Spotnitz, Vinicio Capossela, Nada, Enrico Rava, Gianni Vattimo solo per citarne qualcuno), tutti complici di questo rito collettivo: il chiudersi di un cerchio, il ritorno a casa dell’eroe dopo la sua odissea.
John Fante è però stato in Italia per il suo lavoro di sceneggiatore. Nelle lettere che scrive da Roma ha un giudizio molto negativo del suo popolo di origine, una preoccupazione che condivide proprio con il figlio Dan:
“Gli italiani sono farabutti, ladri, malversatori, bugiardi, truffatori. Mi danno la nausea. Sii contento del tuo lato tedesco e inglese4. E soprattutto sii contento di essere americano. Per quanto riguarda me, vorrei essere un Ubangi con un osso nel naso.”5 Ma subito dopo Fante sembra quasi pentirsi delle sue parole, deve tornare in lui quel “ricordo di vecchie camere da letto, e il ciabattare di mia madre verso la cucina”6. Aggiunge infatti:
“Ma credo sia così per Roma, città di ladri, e che in provincia sia diverso.
Mi dicono che gli abruzzesi sono gente molto per bene.”

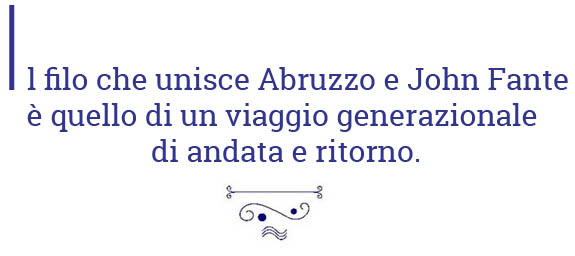
Una storia di amore e odio dal passato utile a comprendere le difficoltà del nostro presente.

1.Traduzione di Caro Corsi, Aspetta Primavera, Bandini, Einaudi, 2005.
2.Traduzione di Alessandra Osti, Full of life, Einaudi, 2009.
3.John Fante festival “Il Dio di mio padre” direzione artistica di Giovanna Di Lello organizzato dal Comune di Torricella Peligna dal 2006.
4.Da parte della madre Joyce Smart, sposata da Fante nel 1937.
5.Da Tesoro, qui è tutto una follia, a cura di Francesco Durante, traduzione di Alessandra Osti, Fazi editore, Roma.
6.Dalla nuova prefazione di Fante a Aspetta primavera, Bandini.


























