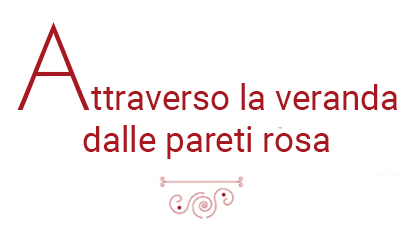Ma fu durante il regno di Tigrane II d’Armenia detto “il Grande” (95 a.C. – 55 a.C.) che l’Armenia ebbe i confini più estesi della sua storia e il massimo grado del suo potere, divenendo così lo Stato più potente del Vicino Oriente. I suoi confini andavano dal Mar Caspio al Mar Mediterraneo includendo non solo l’Armenia orientale (Armenia Maior) ma anche quella occidentale (Armenia Minor) e altri territori della Mesopotamia, della Siria, del Ponto, della Cappadocia, della Cilicia e della Media Atropatene. Mai più gli Armeni avrebbero controllato una così ampia fascia dell’Asia
Tigrane era noto per essere un ammiratore della cultura greca e volle seguire
la tendenza ellenistica dei governanti che fondavano nuove città.
Così Tigranocerta (Tigranakert), fu da lui fondata nell’83 a.C.
anche grazie al bottino ottenuto dall’invasione della Cappadocia, e ne fece la capitale del nuovo Impero dell’Armenia. Non essendoci prove archeologiche, l’ubicazione precisa della città non è nota, oltre al fatto che si trovava da qualche parte nel sud-ovest dell’antica Armenia che, data la recente espansione del regno, era in una posizione più centrale rispetto all’antica capitale di Artaxata (Artashat). Secondo fonti storiche antiche doveva trovarsi nei pressi di Nissibin, ai piedi delle colline di Tur-Abdin e, sempre secondo le medesime fonti, la città era molto ricca e rivaleggiava con la famosa Ninive per quantità di palazzi, giardini e parchi. Tigranocerta aveva un’architettura sostanzialmente ellenistica, sebbene fosse stata progettata per mischiare i tre stili, greco, persiano e armeno.
Aveva mura alte 50 braccia (antica unità di misura che indicava 25 metri) e così larghe che alla base riuscivano ad entrarci le stalle per i cavalli.
Il palazzo reale era circondato da un immenso parco con ampi spazi per la caccia
e laghetti per la pesca, e vicino al palazzo un forte di protezione
Per popolare questa città, Tigrane fece arrivare molti sudditi da altri luoghi, così che ne diventassero i nuovi abitanti. Venne fatta trasferire buona parte della nobiltà armena e molte famiglie di origine greca provenienti dall’Asia Minore. A questi si aggiunsero sudditi provenienti dal Gordiene, dall’Assiria, dalla Mesopotamia araba e da altre regioni conquistate.
Essendo il centro di un prospero impero con collegamenti commerciali sia con la Mesopotamia che con la Fenicia, la ricchezza era interminabile, come riporta Plutarco:
“La città era anche piena di ricchezze… poiché
ogni privato e ogni principe gareggiavano con
il re nel contribuire al suo accrescimento e
ornamento…” (Lucullo, 26:2)
La leggendaria ricchezza di Trigranocerta in quel momento è riportata anche dallo storico armeno Movses Khorenatsi nella sua Storia degli Armeni:
“Moltiplicò le scorte d’oro e d’argento e di pietre
preziose, di abiti e broccati di vari colori, sia
per uomini che per donne, con l’aiuto dei quali il brutto
appariva meraviglioso come il bello, e il bello
era del tutto divinizzato in quel momento… Portatore
di pace e prosperità, ingrassava tutti con olio e miele”.
(citato in Hovannisiano, 56-7)
Una città così prospera attirò persone da ogni parte e molti filosofi e retori greci
furono invitati a condividere le loro idee alla corte di Tigrane.
Per inaugurare il teatro della capitale furono anche chiamati attori greci. La natura cosmopolita della città, e dell’impero in generale, faceva sì che la lingua greca fosse utilizzata, insieme al persiano e all’aramaico, come lingue della nobiltà e dell’amministrazione, mentre i cittadini comuni parlavano l’armeno. Elementi persiani continuarono ad essere una parte importante nella cultura armena, specialmente nel settore religioso e delle formalità di corte come titoli e abbigliamento.
Tigrane aveva costruito un grande impero ma fece un grave errore di valutazione quando si alleò con Mitridate, il re del Ponto (120-63 a.C.). Alleanza che fu anche rinsaldata con il matrimonio nel 92 a.C. fra Tigrane e la figlia di Mitridate, Cleopatra. Mitridate era un grande nemico di Roma, con cui guerreggiava da oltre due decenni.
La repubblica romana vedeva il pericolo di una simile alleanza tra le due potenze, sospetto confermato da una campagna congiunta Tigrane – Mitridate
contro lo stato cliente romano della Cappadocia.
I romani risposero attaccando il Ponto e quando Mitridate fuggì alla corte di Tigrane nel 70 a.C., chiesero la consegna del suocero scappato. Tigrane rifiutò, rispondendo che non avrebbe mai consegnato Mitridate e che se i romani avessero iniziato la guerra si sarebbe difeso. I romani così invasero l’Armenia.
Tigrane fu sconfitto da un esercito romano di 15.000 uomini comandato dal generale Licinio Lucullo che inviò Sestilio a saccheggiare il palazzo reale fuori le mura. Tigrane aveva raccolto più di 100.000 uomini e li usò subito per intercettare Lucullo. Questi avendo visto il nemico prepararsi alla battaglia preparò il suo esercitò., dando l’ordine di attaccare più in fretta possibile.
Tigranocerta fu assediata il 6 ottobre del 69 a.C. come descritto da Plutarco:
Lucullo attraversò il fiume, e si aprì la strada
contro il nemico di persona. Indossava una corazza
d’acciaio a scaglie scintillanti, e un mantello
con nappe, e allo stesso tempo sguainò la spada dal
fodero […] e ordinò ai suoi cavalieri gallici e di Tracia
di attaccare il nemico sul fianco, e di parare
i colpi delle loro lunghe lance con le loro spade
corte” (Vita di Lucullo, 27.5-6; 28.1-2)
Lucullo con la fanteria aggirò gli avversari, il panico si diffuse tra gli armeni e i catafratti travolsero il loro stesso esercito. Poi, in seguito al tradimento della guarnigione greca che aprì le porte ai romani, Tigranocerta fu catturata e saccheggiata.
I romani conquistatori rimasero stupiti dalla ricchezza di Tigranocerta anche dopo che Tigrane era già riuscito a sottrarre parte del suo tesoro reale e dell’harem personale.
Plutarco racconta che i saccheggiatori trovarono 8000 talenti in oro mentre
ogni legionario romano ricevette 800 dracme. La popolazione
che era stata chiamata da Tigrane fu lasciata libera
di tornare nelle proprie terre d’origine.
Lucullo si mosse quindi per attaccare Tigrane e Mitridate nei pressi dell’importante città di Artaxata, ma la battaglia di Artaxata non ebbe esiti decisivi per nessuna delle due parti. In più con l’arrivo dell’inverno, la sua linea di rifornimenti era pericolosamente sottile ed esposta, e un ammutinamento tra le sue stesse truppe costrinse il generale romano a ritirarsi dal nord, tornando verso sud. Dopo otto anni di campagna in Armenia, Lucullo non riuscì mai a sconfiggere definitivamente Tigrane e i suoi alleati, per questo fu richiamato a Roma nel 67 a.C.
La tregua non sarebbe durata a lungo poiché il Senato romano aveva approvato
la determinazione di imporre la sua autorità sulla regione una volta per tutte.
Nel 66 a.C. un altro esercito romano si diresse verso est, questa volta guidato da Pompeo Magno. Questo non solo mise in rotta l’esercito di Mitridate ma fece arrendere anche l’ultrasettantenne Tigrane. La sua resa portò alla fine del conflitto e alla perdita di tutte le conquiste del regno armeno sotto la sua guida. Pompeo trattò generosamente Tigrane a patto che rinunciasse alla Siria e all’Asia minore e pagasse un riscatto di 6000 talenti d’argento. In cambio rimase re dell’Armenia fino alla sua morte come suddito di Roma.