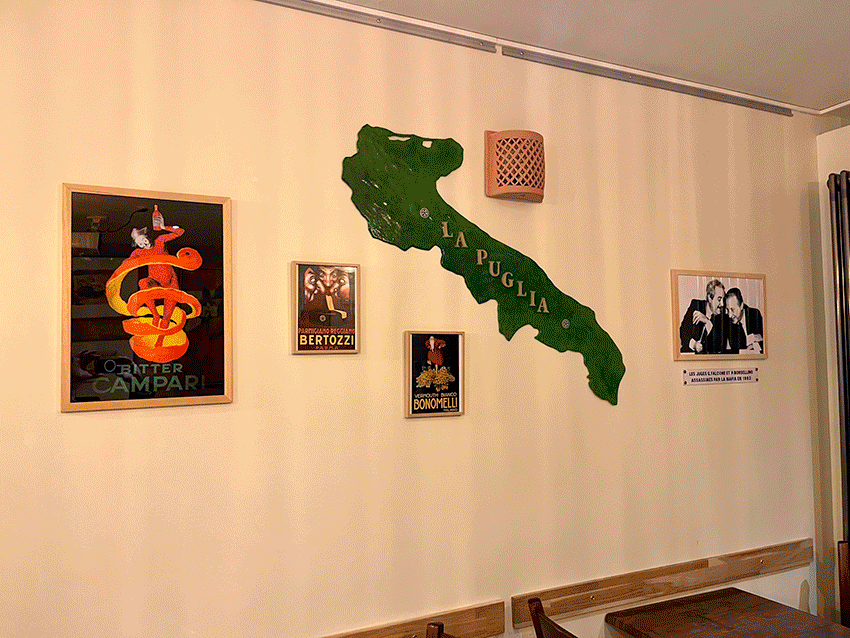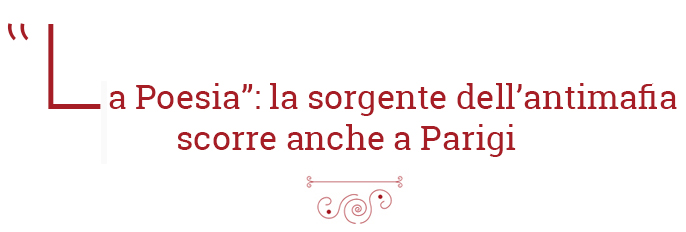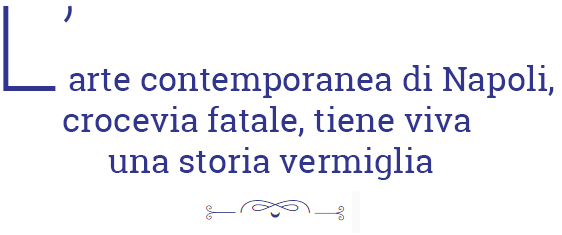Al centro di una doppia trasmutazione alchemica, per così dire – che consta della devitalizzazione dell’organico e quindi della vitalizzazione dell’inorganico, a garanzia di uno splendore imperituro, nodo di remoti commerci tra Mediterraneo e Oriente, legame tra il folklore del passato e il lusso folklorico del presente – risiede
uno dei più pregiati doni del Sud: il corallo.
È risaputo che dal 3500 a. C. l’uomo appendesse corni animali sull’uscio delle proprie caverne, gesto apotropaico. Noto che dagli scavi di Pompei ed Ercolano siano affiorati, tra i molteplici reperti, anche enigmatici cornicelli.
Dall’antica Roma Plinio il Vecchio, nell’enciclopedica Naturalis Historia, descrive le spade dei Galli come decorate in oro rosso.
E nel Medioevo pillole coralline rappresentarono un portentoso farmaco contro crisi epilettiche, incubi e malattie infantili.
Tutti sanno infine che nel Meridione il corno di corallo è simbolo di buona sorte. Lungi da interpretazioni freudiane esso rappresenterebbe, nella forma, il fallo di Priapo, antica divinità simbolo della forza generativa maschile e della fecondità della natura.
E benché dal diario di Marco Polo – che raccontò dei corallini ornamenti indiani
e degli amuleti nepalesi, degli utensili tibetani e degli elmi e dei copricapi mongoli
o ottomani – affiori in sottoparlato il profilo di una via del corallo, accanto
alla via delle spezie e a quella della seta; benché percorrendo
la vesuviana cittadella di Torre del Greco o i vicoli partenopei,
possiamo ancora scorgere il profilo di questa via,
ci accorgiamo lo stesso di un rischio imminente.
Non possiamo non constatare – in questo ventunesimo secolo di humana historia – una crisi auratica dilagante, un dissolvimento cultuale della materia dalla quale perfino il sacro corallo sembra non avere scampo. Qualsivoglia oggetto di pregio, quando non davvero rituale, per non soccombere alla scadenza effimerica dell’oggi, abbisogna di un gesto salvifico in controtendenza.
Soffermiamoci su quel sublime olio su tavola rinascimentale che è La Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, laddove il bambino Gesù indossa un ciondolo di corallo, monito del futuro sacrificio. Soffermiamoci sulle Sette Opere di Misericordia dell’ultimo Caravaggio, che al corallo si lega non per iconografia, ma per significazione, poiché nulla di più misericordioso e caritatevole esiste del sangue versato per l’Altro. Corallium sanguinis imago. E scopriamo come un modo vi sia – offerto proprio da Napoli, città sirenica, partenopea, feconda di risorse – per ritrovare alfine l’aura del Corallium Rubrum, sopravvissuta in resilienza.
Entro la napoletana chiesa ottagonale del Pio Monte della Misericordia,
in via dei Tribunali – fondata nel 1602 grazie a sette nobili caritatevoli
che offrivano assistenza ogni venerdì presso l’ospedale degli Incurabili –
si trovano, in forma permanente, dal 2019, quattro sculture realizzate
dall’artista contemporaneo Jan Fabre (Anversa, 1958).
In dialogo con i dipinti seicenteschi delle sette cappelle d’intorno
e con l’opera del Merisi, posta sull’altare: si tratta di una tetragonia
di sculture fatte interamente di corallo.
L’artista belga, amante di Caravaggio e di Napoli, che non a caso ha dato a suo figlio il nome Gennaro, è legato al concetto di Caritas e ha scelto il corallo per risvegliarne la storia a partire dalla tradizione culturale e pittorica barocca. Il filo rosso – più rosso non potrebbe dirsi – che lega le sculture fiamminghe è la presenza, in ciascuna, di grossi, guizzanti cuori anatomici. Di volta in volta associati a simbologie cristologiche.
Nella Purezza della Misericordia, ispirata alla tela del Merisi, ove Sansone eroe biblico, beve dalla mascella di un asino, questa è la base ossea su cui si regge il cuore umano, dal quale sbocciano magnifici gigli, simbolo della purezza della Vergine Maria, cui la chiesa è dedicata. La colomba con ramo d’ulivo è il soggetto corallino de La Libertà della Compassione, dove il cuore umano è stretto fra catene. E lo stesso cuore è circondato di edere nella Rinascita della Vita, a omaggiare il ciclo di vita, morte e resurrezione. Mentre nella Liberazione della Passione il cuore di corallo si fa serratura ed accoglie le chiavi del Paradiso di San Pietro.
Perché adempia al suo compito di portare fortuna il corallo dev’essere ricevuto
in dono, non acquistato, infatti le opere fabriane sono state donate dal fiammingo
al Pio Monte della Misericordia, grazie al sostegno di Gianfranco D’Amato
e Vincenzo Liverino in ricordo dei Cavalieri del Lavoro
Salvatore D’Amato e Basilio Liverino
Questo fa del Pio Monte non soltanto un celebre luogo di culto cristiano e il custode partenopeo di una delle più complesse opere di Caravaggio, ma anche un tempio della Buona Sorte.
Varcando la soglia della chiesa tutto ciò che il corallo taceva torna a galla. Quella storia raccontata da Ovidio, che vuole la rossa viscera splendente generarsi dalle stille di sangue della Medusa decollata da Perseo. La sollecita corsa quattrocentesca all’acquisto di gioielli corallini di Alfonso d’Aragona per soddisfare la vanitas della sua Lucrezia d’Alagno.
La fascinazione che ebbe per il corallo la moglie del re di Napoli Gioacchino Murat, Carolina Bonaparte, che regalò al fratello Napoleone una spada imperiale ornata
di cammei torresi, una scacchiera corallina ed altri gioielli vermigli.
La moda per il Rubrum Corallium che di qui si espanse alla corte di Francia.
Il racconto di qualche viaggiatore d’oggi, che forse si è udito senza troppa cura. Che descrive alcune casupole Polinesiane sull’isola di Huahine, povere e disadorne viste da fuori, ma che all’interno custodiscono ancora pavimenti rivestiti di corallo. E ancora, le colonie degli artigiani di Torre del Greco generatesi in Giappone quando si scoprirono risorse coralline nel Pacifico.
I mercanti ebrei di Livorno e Genova che sovraneggiavano sul mercato corallino, messi in riga dall’ordine giuridico di Ferdinando IV di Borbone. La diaspora quattrocentesca dei fini corallari siciliani che si insediarono in Campania portando le proprie tecniche di lavorazione tra Napoli, San Giorgio a Cremano, amalgamandosi agli artigiani napoletani del corallo.
Questo fa Napoli, città pulsante di segreti. Mischia le carte e sovrappone le storie. Dal mito alla religione, dal lusso d’Oriente, alla moda cortese fino all’arte contemporanea. E lo fa anche attraverso la storia infinita dei rami di corallo.