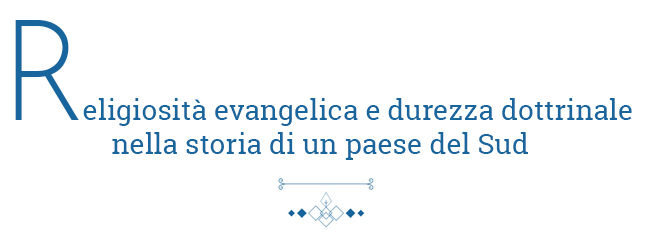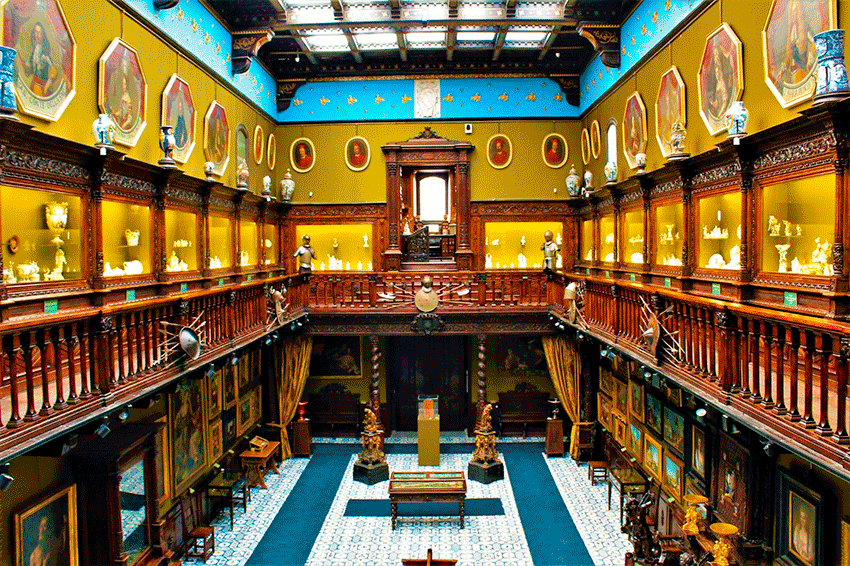UN INCONTRO di gusto
Parte prima – Parte seconda
Anche la cronaca di un evento, nel caso di specie la presentazione di un gran bel libro, già di per sé un momento di particolare interesse, può ancor più arricchirsi fino a trasformarsi in un’occasione per una riflessione sul meridione d’Italia, sul nostro SUD, sui suoi valori, sulle sue tante storie e sulla ricchezza emotiva che da sempre ha espresso, esprime ed in prospettiva potrà ancora garantire al nostro Paese rendendolo così unico e straordinario
“Campagna letteraria” è un’iniziativa cui il Pastificio La Molisana ha dato avvio da qualche storico tempo a favore della Città di Campobasso che ospita l’azienda che con il suo marchio è da anni presente sulle tavole degli Italiani, famoso nel mondo e leader della buona cucina.
Nata in sordina, con quella discrezione un po’ ritrosa che è una cifra connotativa
del carattere di questa popolazione, l’idea ha ben presto preso corpo e vigore
di vero progetto per l’attenzione che ad essa ha dedicato l’Azienda e per il successo che i fruitori le hanno da subito tributato.
Uno spazio culturale elegante e raffinato, che, ben contestualizzato in ambientazioni tipiche dell’architettura industriale, ha saputo valorizzare le opere che sempre più incisivamente andavano ad essere scelte e lì presentate.
La sistematica, preziosa e accogliente presenza della proprietà è stata rappresentata in questa occasione dal capostipite della famiglia Vincenzo Ferro che ha assunto il ruolo di conduttore dialogante, competente ed appassionato e da sua figlia Rossella, direttamente impegnata nella conduzione aziendale e protagonista in questa magnifica iniziativa, affiancata come spesso è accaduto anche dal fratello Giuseppe anch’egli primario artefice del successo di questa bella azienda del nostro meridione.
Un’occasione che ha confermato come l’indissolubile miscela di successo, cultura e sentimento partecipativo riesca nel nostro Paese a produrre esempi di qualità straordinaria.
Le poche righe che mi accingo a scrivere, lungi da voler sfiorare l’idea di una critica letteraria, vuole essere soltanto la cronaca di un evento nel quale riconoscere
il perché di una comunità, la qualità di uno stare insieme
e l’affetto per la propria Terra e le proprie origini.
“Vae victis” con questa locuzione latina, che tradotta letteralmente significa “guai ai vinti” lo scrittore Gianfranco De Benedittis ha iniziato a raccontare il suo libro.
Quell’incipit, ha proseguito l’autore, è una espressione proverbiale usata come sorta di sopraffazione nei confronti di un avversario che non è più in grado di difendersi e nello stesso tempo esaltare il potere e la forza dei vincitori, relegando così gli sconfitti ad un ruolo marginale, sminuendone le capacità e l’intelligenza e la stessa legittimazione storica.
Ed in questo pomeriggio l’autore ci vuole condurre, con il suo libro frutto di una sua decennale ricerca documentale, in una archeologia del pensiero storico ricostruttivo, in una indagine socio economica di un passato sepolto dalla polvere del tempo ma non così nei cuori di quanti, seppur eredi di una terribile sconfitta, non hanno mai rinnegato le loro origini anzi ne menano ancora vanto ed oggi, in questa sala, il nostro autore ne diventa nuovo condottiero.
La storia è, infatti, sempre raccontata dai vincitori ma non sempre la ricostruzione
è stata obiettiva e assolutamente veritiera almeno in ogni suo capitolo.
E’il caso del popolo Sannita primo grande oppositore all’espansione e allo strapotere romano, che già lo storico Tito Livio definì “rozzi montanari”.
Lo disse lui, lo ripeterono in tanti e per tanto tempo, tutto senza uno straccio di riprova o una ricerca del contrario; insomma senza difesa alcuna per i vinti.
Un popolo, quello Sannita, che ebbe la “colpa” di aver umiliato la grandezza di Roma. Un affronto che tutti i narratori del I secolo hanno volutamente veicolato nell’oblio, tant’è che nella storia della letteratura romana, cioè tutta, dei Sanniti non è sopravvissuto quasi nulla.
Ma oggi, in virtù di questa poderosa ricerca e dell’opera letteraria che ne è il frutto, si è voluto cercare di restituire al popolo Sannita quel ruolo fondamentale che competeva loro e che la “storia romana”, qui si sostiene, a torto aveva cancellato.
Quella operata dal professore De Benedittis è, infatti, una sistematica e documentata rilettura delle fonti e delle testimonianze che ha così dipanato
i tanti dubbi e le contraddizioni
che lo storico ha fatto emergere nel suo incessante lavoro di scavo archeologico nel sito di Monte Vairano alle porte della città di Campobasso ed in altri numerosissimi insediamenti sparsi in tutto il Molise.
Un territorio, quello molisano, falcidiato da un’emigrazione secolare, mai interrotta ed ancora feroce, isolato da una viabilità che ancora oggi lo vede incredibilmente e deliberatamente escluso dai pur modesti progetti di sviluppo ferroviario e marginalizzato anche da quelli autostradali, che resta comunque non lontano dai grandi centri attrattivi di Roma, Napoli e Bari; ed è così che gli eredi dei Sanniti, nonostante tutto appena possono tornano a casa per partecipare a ricorrenze e manifestazioni che tra sentimenti religiosi e riti pagani rievocano ancestrali usanze.
Insomma, una popolazione sempre fiera del proprio passato nascosto in antichi racconti ed in tradizioni che hanno a che fare con il fuoco ed il ferro e con uno spirito che ancora esalta nei racconti riservati ai bimbi la forza ed il coraggio di chi nei secoli ha dovuto battersi con i lupi e di quelle pelli si copriva in guerra.
Una Terra per dirla come scrisse F. Jovine che “è per me un sogno. Un mito tramandatomi dai padri e rimasto nel mio sangue e nella mia fantasia.”
Quella Regione che qualche cattivo scolaro ancora stenta geograficamente collocare sulla cartina politica “muta” dell’Italia che pur abbiamo avuto tutti tra le mani nella scuola dell’obbligo e che persino il servizio televisivo delle previsioni del tempo ancor oggi fatica a collocare tra il sud del centro ed il nord del sud.
Ma al di là del gioco sul “Molise che non esiste”, ormai utilizzato proprio per decantarne la straordinaria bellezza naturistica, le incontaminate realtà civiche e le preziosità salutistiche di aria ed acqua, oggi, con questa ricerca scientifica, sono state poste in discussione e persino cassate anche certe finora indiscusse connotazioni sulle sue origini ed in particolare sulla qualità delle società che quei territori avevano abitato nel passato remoto.
(segue)