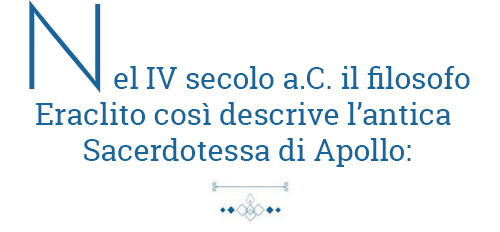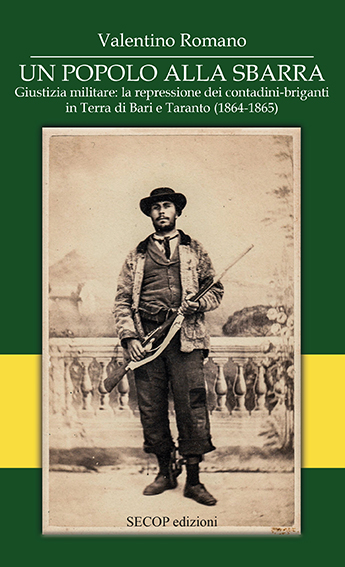Villa Lysis, la reggia degli eccessi nel cuore di Capri
quando l’ardente sole ti asciuga sulla spiaggia, ah, lasciami sognare, e fare un bel viaggio… il tuo corpo è uno scrigno misterioso e chiaro…»
Jacques Fersen
Un triangolo amoroso quello tra il barone-poeta francese Fersen, le tentazioni e la natura incontaminata dell’isola di Capri.
Proprio come il suo contemporaneo Oscar Wilde, Jacques Fersen credeva che l’unico modo per liberarsi dalle tentazioni fosse cedervi, e così fece per tutta la sua vita fin quando, nel 1903, subì un lungo processo che portò alla luce feste compromettenti, lettere d’amore indirizzate ad un giovane ed altri scandali.
Il dandy decadentista e scrittore trovò allora rifugio tra le bellezze dell’isola
che aveva visitato già a diciassette anni e dalla cui bellezza
era stato come folgorato,
colpito nella sua sensibilità estetica, ammaliato dalla potenza del vento che cantava sugli scogli e dalle onde di acqua cristallina che si increspavano lente verso l’orizzonte.
Per porre le fondamenta della sua villa scelse un luogo selvaggio, scolpito dal tempo, posto davanti ad un panorama mozzafiato: la rupe di Tiberio.
In dodicimila metri quadri di terra l’architetto e scenografo Chimot
progettò una villa in stile Luigi XVI,
in cui l’eleganza e l’esagerazione trasudavano da ogni poro come in un teatro dell’epoca. All’interno, stucchi, colonne, legni e materiali pregiati impreziosivano le stanze bagnate dalla luce del sole di Capri, riflessa nei mosaici dei vetri colorati.
La palazzina era contornata da terrazze a strapiombo sul mare, da grandi finestre da cui penetravano i profumi e le fragranze del giardino esotico composto da orchidee, azalee, rose e camelie; copie di statue romane animavano la natura del boschetto d’alloro e del mirto dedicato al mito della bella Venere, mentre la villa era dedicata a Liside, discepolo ed amico di Socrate. Ma le bellezze della natura ed il sole del Mezzogiorno non dettero pace al giovane Fersen, neanche quando, ispirato dai suoi versi, si specchiava nel mare cristallino cercando la propria anima sul fondale in mezzo ai pesci ed alla flora marina;
egli, mosso dal suo spirito inquieto, animò la villa di feste e di balli, di scandali
e di eccessi. Villa Lysis divenne così il ritrovo per artisti e letterati dell’epoca.
Nell’atrio vi era un’immacolata scalinata di marmo dalla balaustra in ferro battuto, di fronte alla quale faceva capolino la grande biblioteca; al centro, una copia del David di Varrocchio sorrideva, forse schermendo i suoi ospiti. Oltre il salone, una veranda composta da piastrelle azzurre si mostrava al Golfo di Napoli attraverso le finestre, occhi affacciati sul Vesuvio che faceva da sfondo, incerto se eruttare il fuoco della terra, mentre il soffitto a cupola era contornato da colonne corinzie intarsiate d’oro.
Al piano superiore si trovava la camera di Fersen, esagerata, sfarzosa, imprudentemente affacciata sul mare e sul Monte Tiberio, accanto quella di Nino, suo compagno ed amico, oltre ad una camera per gli ospiti ed una grande sala da pranzo.
Superati gli archi della veranda si scendeva in basso e, attraversati gli inferi dell’animo umano, si trovava la fumeria d’oppio chiamata “La camera cinese”.
“Amori et dolori sacrum”, ovvero “luogo sacro all’amore ed al dolore”
era la frase tratta da un’opera di Maurice Barrès, l’iscrizione latina
che il barone volle apporre all’entrata della piccola sala da fumo.
Nell’alcova pietre dure, vassoi d’argento e pipe intarsiate comprate durante un viaggio ad Hong Kong adornavano la stanza in cui si rifugiava per sprofondare nei sogni ovattati dall’oppio, per cercare pace e riparo dalla sua stessa vita ed in cui morirà suicida, chiudendo il cerchio di un’anima inquieta divisa tra gli eccessi ed un’ideale di purezza che lo spinse sempre a narrare il bello.
Una morte vissuta come ultimo atto sul grande palcoscenico della vita, la fine cercata durante un temporale, illuminata soltanto dalla luce di una manciata di candele rosa e che ci lascia perplessi a contemplare i suoi versi:
«Stasera canto l’oppio, l’oppio illimitato, il sommo oppio. Danza il suo fumo nel cervello e l’uomo me lo involve nell’oblio. Guardo il fantasma inebriato; divento i suoi veli imponderabili, ascolto la sua voce che promette estasi ed entro in pagode profumate di gelsomini ove ardono resine per gli avi».
Dei suoi romanzi e poesie è reperibile in italiano la traduzione dell’autobiografia
E il fuoco si spense sul mare, edito nel 2005, e Amori et dolori sacrum.
Capri, un’infinita varietà:1905-1923: l’isola di Jacques Fersen, del 2009.
Villa Lysis ha ospitato tanti personaggi: Hans Paule, Gilbert Clevel, Otto Sohon-Rethel, la marchesa Luisa Casati e la famosa poetessa Ada Negri, che in un articolo sull’Ambrosiano del 1923 scrisse:
«(…) tutto era troppo bello, compreso Nino, il segretario dal profilo di medaglia, con lo sguardo di chi ha occhi troppo lunghi, troppo neri e sormontati da sopracciglia troppo basse; ed il suo padrone, gentiluomo di gran razza, cortese, dall’altera eleganza, che parlava il più perfetto francese e leggeva versi come nessun’altro» riferendosi a Nino Cesarini, amante ed amico del Fersen che da lui eredita la proprietà.
La villa passò poi alla nipote di Fersen, ma nel 1985 il Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali vincolò la proprietà, che venne restaurata negli anni ’90 con i fondi dell’Associazione Lysis e del Comune di Capri per essere riaperta al pubblico.
Per chi oggi visita l’isola vale la pena salire sul promontorio settentrionale da via Sopramonte continuando per via Tiberio, per giungere infine tra le quattro colonne ioniche della villa tra i fantasmi del Fersen, dei suoi amanti e dei letterati dell’epoca, per poi riprendere fiato nel bel giardino, davanti ad un panorama mozzafiato.
Che non si cada però nella tentazione di giudicare la vita di Jacques Fersen, nipote di un facoltoso industriale, discendente diretto del conte Fersen, maresciallo di Svezia ed amante della regina Maria Antonietta, quel giovane poeta che di quella sua vita aveva fatto lo specchio di eccessi e di misteri, perché, come sosteneva Wilde, è meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita.