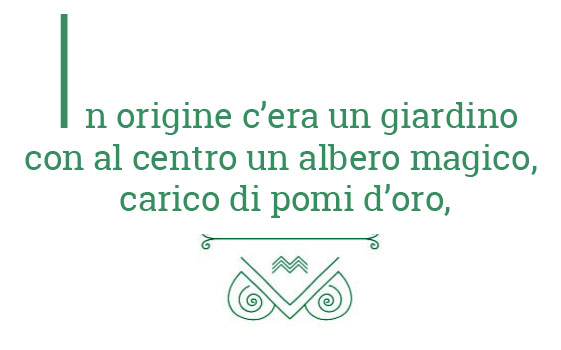LA BARCA
DI ISIDE
IL PAPIRO E
LA SCRITTURA
Cosa non può l’ingegno?
Ecco che il palustre papiro,
ridotto dalla lama in strisce larghe e sottili,
dà ai mortali lo strumento della carta.
Allora per la prima volta gli amici lontani
poterono mandare e ricevere dolci messaggi.
Vennero poi i codici in onore:
allora tutti ad esercitare l’animo con gli studi,
a dirozzare le menti incolte:
il papiro raffinò il cuore dell’uomo
e tanta scienza si dispiegò in tanti libri”.
(Jean Imberdis, 1693)
Quest’antica scritta accoglie i visitatori del Museo del Papiro di Ortigia (Siracusa), un piccolo gioiello incastonato nell’ex convento di Sant’Agostino fondato dai professori Corrado Basile e Anna Di Natale nel 1987, unico museo esistente interamente dedicato al papiro e ai suoi usi, che nel 1995 per la sua importanza scientifica e didattica, è stato inserito nell’elenco finale dei musei selezionati per il prestigioso premio European Museum of the Year. L’ignaro visitatore che si appresta ad attraversare il portone dell’ex convento non può minimamente immaginare quale universo gli si stia per aprire davanti,
un mondo incantato di reperti in papiro che riportano
agli albori della civiltà.
Sì, perché il papiro Cyperuspapyrus L. non è solo la pianta da cui si traeva il materiale per gli antichi fogli ad uso scrittorio ma è una specie erbacea perenne che consente la produzione – e così è stato in Egitto sin dal 3.000 a.C. e poi in Palestina e in tutto il mondo greco-romano – di particolari corde, vesti, calzature, recipienti e anche piccole imbarcazioni. Sono proprio tre leggere barche in papiro uno dei fiori all’occhiello del Museo del Papiro.
Nei suoi viaggi di ricerca in Africa, il professor Basile si recò prima
in Etiopia, dove recuperò due delle tre barche presenti al museo costruite nei laghi Tana e Zwai,
e dopo nel lago Ciad, dove andò sia per studiare l’origine della pianta e i tassi di crescita nelle diverse condizioni ambientali, sia per documentare i processi di costruzione delle barche con la tecnica usata dai pescatori Buduma, e dove riuscì ad ottenere una delle ultime “kedeje” con la poppa tronca e la prua rialzata. Le tre barche gli furono anche richieste da un importante museo all’estero, ma lui le ha sempre custodite, rendendole parte integrante dei beni stabili del suo Museo del Papiro. D’altra parte, oltre ad essere degli esemplari rarissimi, rappresentano secoli di storia, tradizioni e leggende. Le barche in papiro, infatti, hanno una storia antichissima, basti pensare che ne abbiamo testimonianze da autori antichi e anche nei passi biblici. Come ci ricorda il prof. Basile, Isaia descrive i viaggi degli ambasciatori etiopi dall’Egitto alla Palestina su barche di papiro, e nell’Esodo è scritto che la madre di Mosè mise il figlio in un cestello di papiro.
Altre testimonianze antiche narrano la leggenda secondo cui
in nessun caso un coccodrillo avrebbe attaccato chi navigava
su un’imbarcazione in papiro per rispetto alla dea Iside
che ne aveva utilizzata una lungo il Nilo alla ricerca
del corpo straziato del marito Osiride.
Ma questo è solo un tassello della ricca collezione del Museo. Oltre alle imbarcazioni,
il museo espone la collezione di papiri faraonici del XV sec. a.C.,
ieratici, demotici, greci, copti e arabi, poi alcuni manufatti in papiro,
come corde, che fabbricate nell’antico Egitto venivano esportate
in tutto il Mediterraneo,
sandali, fabbricati sin dall’epoca faraonica, e recipienti utilizzati per conservare cibo o altri materiali; infine anche i papiri prodotti a Siracusa dal XIX secolo, con la manifattura della carta di papiro e i materiali e strumenti scrittori, come pigmenti di alcuni colori, penne e palette. Il ruolo svolto dal Museo del Papiro non è solo quello riguardante la parte museale vera e propria, ma è anche tutto ciò che concerne la ricerca scientifica e storica, gli studi sulla pianta, sul trattamento della carta papiracea e sulla conservazione dei papiri antichi. Non meno importanti gli studi sull’origine del papiro in Sicilia e l’uso della pianta nelle varie culture.
Nel 2017 il Museo del Papiro, attraverso i due soci fondatori, è stato premiato dal Museo Egizio del Cairo per essere stato promotore
sin dal 1998 del “Progetto di restauro dei papiri in Egitto”
in collaborazione con istituzioni culturali e scientifiche egiziane, con lo scopo di favorire l’attività di ricerca e di studio nel campo del restauro dei papiri antichi, nonché per la creazione del più grande “Laboratorio di restauro dei papiri” all’interno del Museo Egizio del Cairo, che è operante dal 2005. Il Museo del Papiro di Siracusa è l’unica istituzione ad aver ricevuto dal Museo Egizio del Cairo un così importante riconoscimento, cui si aggiunge il decreto governativo che nomina Corrado Basile consulente per tutti i progetti di restauro dei papiri in Egitto.
Poiché le radici ci riportano spesso a casa, tra i vari rami di studio,
il professor Basile si dedica anche all’indagine storica del papiro
in Sicilia e alla tutela della pianta nell’ambiente fluviale
del fiume Ciane e dei papiri della Fonte Aretusa di Siracusa.
Il papiro è presente lungo le sponde del Ciane, il fiume di mitologica e storica fama che scorre a pochi chilometri da Siracusa. La caratteristica che rende unica quest’area protetta è che, se si esclude la piccola colonia di Fiumefreddo di Sicilia (Catania), il papiro del fiume Ciane è considerato l’ultimo superstite di una maggiore presenza in Sicilia nel versante orientale e in quello meridionale, ed è in assoluto la più grande colonia europea di Cyperuspapyrus L. Ma i papiri sono presenti fino nel cuore di Siracusa, a Ortigia, all’interno della Fonte Aretusa, uno dei monumenti più importanti e visitati della città, le cui piante sono state affidate alla cura e al mantenimento del Museo del Papiro, che peraltro possiede un’ampia documentazione archivistica delle piante della Fonte. Di questa fonte con i suoi papiri rimase affascinato anche Orazio Nelson che, quando sostò a Siracusa nel 1798, prima di affrontare Napoleone ad Abukir scrisse: “Grazie ai vostri sforzi noi ci siamo riforniti di viveri ed acqua, e sicuramente avendo attinto alla Fonte Aretusa, la vittoria non ci può mancare”. Nei secoli il papiro è stato utilizzato dai pescatori siracusani per intrecciare corde o dai contadini per legare covoni,
mentre le ampie chiome verdi erano impiegate come decorazione
per ricoprire pavimenti di strade e chiese durante le festività.
Inoltre grazie alla vasta presenza della pianta, Siracusa sviluppò la produzione di carta di papiro sin dall’antichità per arrivare ai giorni nostri con alcune piccole eccellenze. Il prof. Basile ha iniziato a occuparsi negli anni Sessanta delle antiche tecniche di fabbricazione della carta di papiro e del restauro conservativo dei documenti papiracei antichi e oggi, all’interno del suo museo, spiega ai visitatori e agli studenti la manifattura della carta papiracea. Per riassumere in poche parole
come sia possibile da una pianta arrivare a un foglio ad uso scrittorio,
si utilizza la porzione mediana del fusto raccolto nel momento di più idonea maturazione. Il fusto è liberato dalla scorza e tagliato in strisce (lunghe anche 40 cm). Dopo il pretrattamento con particolari soluzioni, le strisce vengono appoggiate su un panno e sovrapposte di qualche millimetro, formando un unico strato. Si procede poi con un secondo strato disposto perpendicolarmente al primo. Il tutto viene poi pressato con un torchio o un rullo. Traslando un nostro modo di dire molto conosciuto, possiamo in conclusione affermare che “del papiro non si butta via niente”. Abbiamo visto la vasta quantità di oggetti che venivano prodotti con questa pianta, ma non è finito: le ombrelle infatti erano usate anche nelle feste e nei riti funebri, i germogli più teneri venivano mangiati, lessi, arrosto o crudi, succhiando la parte più liquida e gettando la polpa, i rizomi erano utilizzati come ottima legna da ardere.
Così lo studio, la cura e la conservazione di questa straordinaria pianta hanno trasformato un piccolo museo di una città del sud
in un’eccellenza internazionale,
con i suoi fondatori chiamati a partecipare a campagne di scavo in Egitto, convegni internazionali, inaugurazioni di biblioteche e musei in Egitto, pubblicazioni su riviste scientifiche, cattedre universitarie e riconoscimenti pubblici.