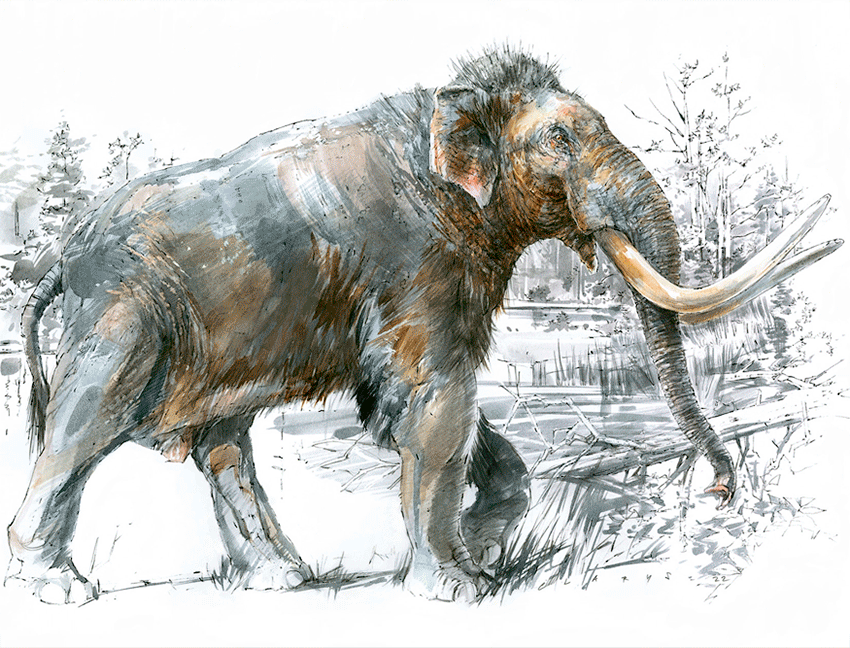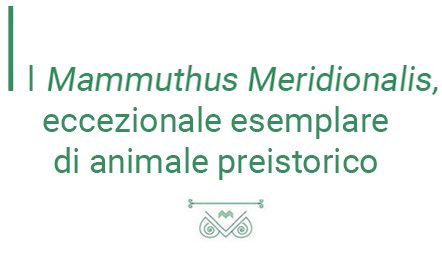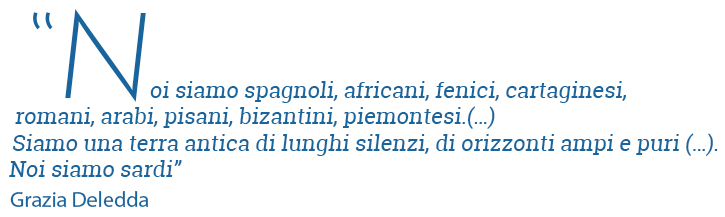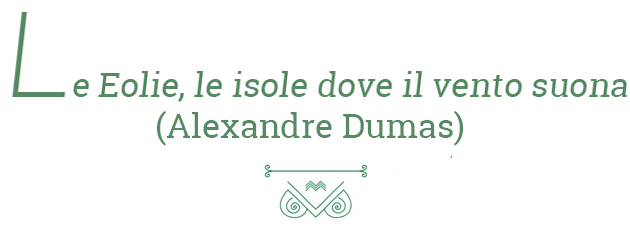è stata interessata dal declino di interi comparti produttivi (soprattutto nei settori di base quali siderurgia, chimica, ecc.) che ha inaugurato la stagione della dismissione e, conseguentemente, della formazione di quelli che i geografi chiamano “vuoti urbani”. Infatti, il ridimensionamento delle attività produttive e le politiche di delocalizzazione e decentramento produttivo hanno stravolto gli assetti territoriali, per l’abbandono di molte aree un tempo occupate da imprese che, in molti casi, sono rimasti inutilizzate.
Tuttavia, questo processo non ha interessato solo le strutture industriali,
ma anche numerosi complessi del terziario che hanno visto perdere
progressivamente la propria funzionalità per la ridistribuzione
nello spazio urbano di molte attività economiche.
Tutto ciò è avvenuto in contesto di un’economia di per sé debole; in particolare, ad essere interessate da questi fenomeni, sono state soprattutto le periferie orientale e occidentale di Napoli le quali, sin dall’età borbonica, per le favorevoli condizioni territoriali – morfologiche e di accessibilità – hanno rappresentato le aree preferenziali per la localizzazione di impianti industriali che, nei decenni successivi, sono state affiancate da molti altri stabilimenti di diversi comparti produttivi progressivamente dismessi. In assenza di una pianificazione illuminata ed innovativa, queste aree hanno finito col trasformarsi in spazi degradati, avulsi dai loro contesti territoriali, abbandonati e motivo di rischio per l’uomo e per l’ambiente
Al vuoto ed al degrado occorre reagire e, sebbene in modo stentato e talvolta contraddittorio, si sta faticosamente facendo strada la tendenza a considerare strategico, per il recupero di queste aree, puntare su settori produttivi
caratterizzati da un maggiore contenuto di conoscenza.
In altri termini, l’innovazione scientifica e tecnologica assume rilievo cruciale, così come la capacità delle imprese più dinamiche ed innovative di inserirsi in un contesto territoriale favorevole, caratterizzato dalla presenza di centri di ricerca ed università.
In questa dimensione si rivalutano anche le città nelle scelte di insediamento delle imprese e si accentuano i processi di concentrazione dell’attività economica anche all’interno delle stesse regioni. Nel 2025, secondo una ricerca McKinsey, in 600 città globali il 66% della popolazione del mondo produrrà due terzi del Pil mondiale e la competizione vedrà sempre più coinvolte le grandi aree metropolitane ricche di connessioni.
Una certa narrazione vede in Napoli la città del Teatro, della Musica e delle bellezze naturali, si dimentica però che il capoluogo campano è sede della più antica università pubblica d’Europa istituita dall’Imperatore Federico II nel 1224 e che vanta una prestigiosissima tradizione nel campo della ricerca scientifica, si pensi soltanto all’istituzione della prima cattedra di genetica in Italia.
La presenza di un forte polo universitario – ben cinque atenei – in campo scientifico è condizione necessaria per consentire anche la nascita ed il rafforzamento di imprese ad alta tecnologia.
In questi ultimi anni si possono segnalare varie iniziative
che vedono il coinvolgimento – faticoso – di soggetti pubblici e privati che si muovono in questa direzione tanto nella periferia ovest che in quella ad est della città partenopea. Sul versante occidentale, nel quartiere di Bagnoli, ai margini dell’area ex-industriale dell’Italsider, due consorzi di imprese sono impegnati nella realizzazione di un Polo Tecnologico per ospitare uffici e laboratori di ricerca e sviluppo, sia per le proprie aziende, sia per le altre che gradualmente vorranno insediarsi in un comprensorio con grandi potenzialità.
Si prevede di costruire Laboratori ed uffici per ospitare fino a 3000 tecnici e ricercatori. Oltre ad uffici e laboratori sono previsti parcheggi interrati ed esterni, ampi spazi verdi ed aree per ospitare eventi, show-room, sale riunioni, servizi di ristorazione, commerciali, ricettivi e per la logistica.
La realizzazione di un luogo fisico per aggregare le competenze risulta strategico e consentirà di sviluppare collaborazioni tra le imprese e con enti di ricerca. La condivisione delle conoscenze e delle esperienze realizzative sarà caratterizzata da un elevato livello di innovazione già con gli impianti previsti con la costruzione del Polo Tecnologico.
Con più di 30 imprese ed enti di ricerca, il progetto si presenta con un rilevante programma di investimenti che si svilupperà costituendo un aggregato di personale con alta qualificazione professionale. Il Polo accoglierà centinaia di persone anche dall’estero, che troveranno a Bagnoli uno spazio dove lavorare, soggiornare e trascorrere il tempo libero tra le tante attività ricreative disponibili. Verrà a crearsi così un indotto economico e sociale con ricadute positive sull’intero territorio circostante.
Nel Polo Tecnologico saranno applicate le migliori tecnologie e realizzati servizi innovativi, alcuni in forma sperimentale ed altri già industrializzati,
che potranno essere mostrati e valutati fisicamente, come una grande show-area con possibili ed auspicate estensioni nella circostante e riqualificata area ex-industriale di Bagnoli.
L’intero progetto, come si diceva, nasce dalla collaborazione di due consorzi di aziende, chiamati rispettivamente Polo Tecnologico Ambiente (PTA) e Polo Tecnologico di Bagnoli (PTBagnoli). Questi consorzi riuniscono numerose aziende attive nel campo dell’innovazione, decise a valorizzare insieme il territorio locale attraverso l’eccellenza che dimostrano nelle più avanzate tecnologie. Tra queste Bit4id, Gematica, Graded, IBI, IDI, IPmotive, Itatech, Protom, Sea Costruzioni, e molte altre.
Le competenze delle imprese del Polo Tecnologico sono
di assoluto valore anche a livello internazionale
ed includono, tra l’altro: Valutazione e riduzione dell’impatto dei rischi ambientali da cause naturali e antropiche, Sistemi e servizi di sicurezza informatica, Smart-City: gestione ambiente e infrastrutture, Bonifica di siti contaminati, Tecnologie e materiali ecocompatibili, Energie alternative e gestione integrata dei rifiuti.
Ogni azienda darà vita ad un centro di eccellenza tecnologica, detto anche “TEC – Tecnology Excellence Center”, in cui portare avanti le proprie attività di ricerca applicata e sviluppo. La presenza di tante diverse realtà all’interno del Polo Tecnologico porterà ad un fruttuoso scambio di competenze e know-how.
Il Polo Tecnologico avrà un ruolo fondamentale nei processi di sviluppo economico e sociale del territorio.
Per raggiungere questo importante obiettivo si ispira all’eccellenza già raggiunta
a livello locale in tre diversi ambiti, dove tutti i fattori cooperano,
si influenzano e si arricchiscono vicendevolmente.
A Napoli Est si annovera già la presenza di importanti multinazionali quali la Apple, Cisco, Deloitte, Merck, Accenture, IBM, NTT Data, che operano in collaborazione con le università Federico II e Parthenope in percorsi di formazione ed Academy per giovani e laureati. In particolare, il Digital Innovation Hub promosso da Confindustria opera per facilitare le relazioni tra Industrie, Centri di Ricerca ed altri attori istituzionali. Il Polo Tecnologico di Bagnoli offrirà nuovi spazi per ampliare le presenze qualificate nell’area di Napoli con nuovi centri di eccellenza tecnologica.
Tutto questo si inserisce in un territorio rinomato in tutto il mondo per la sua varietà
e per la sua ricchezza, ed il patrimonio ambientale, culturale e monumentale
di Napoli e dell’intera regione non smette mai di stupire.
Oltre ad essere una continua fonte di ispirazione, la bellezza del territorio è un solido pilastro dell’economia locale che può fungere anche da attrattore turistico.
Spostiamoci ora verso la periferia orientale, dove è stato inaugurato, nel Polo Tecnologico Aerospaziale di via Gianturco a Napoli, il laboratorio “Fabbrica dell’Innovazione” per le attività di ricerca in condizioni di microgravità: una struttura di oltre 1000 mq. E’ stato sottoscritto il contratto tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e la società Ali (Aerospace Laboratory for Innovative Components) per la realizzazione di due Space Box contenenti altrettanti esperimenti di life science che saranno inviati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli Space Box sono laboratori miniaturizzati realizzati dalla società Ali e già qualificati per le attività nello Spazio lo scorso agosto 2021 che consentiranno la totale automatizzazione degli esperimenti.
All’interno del Polo tecnologico Aerospaziale è stato sviluppato
il progetto READI-FP, finanziato dalla Regione Campania,
che nell’ultimo anno ha conseguito risultati davvero significativi con la certificazione del Mini Lab, strumento innovativo per “incubare” esperimenti al servizio della ricerca aerospaziale.
Una fabbrica dell’innovazione in una struttura che in passato ha ospitato una grande fabbrica metalmeccanica, la Mecfond, segna una continuità che è paradigmatica delle potenzialità che questa storica area della città può ancora esprimere al servizio della rinascita di Napoli.
Va anche detto che l’apertura dei nuovi spazi della Fabbrica dell’Innovazione costituiscono un ulteriore elemento di rafforzamento
del Distretto Aerospaziale della Campania.
Quest’ultimo rappresenta ormai una realtà consolidata che si occupa della cura e gestione delle collaborazioni e dello scambio di know-how in ambito internazionale, nonché della promozione di partnership tra mondo imprenditoriale, istituzioni, università e centri di ricerca che favoriscano processi di cross-fertilization a supporto della creazione di nuove tecnologie, della loro diffusione e del loro trasferimento nel settore aerospaziale.
Il modello del distretto si è rivelato a 10 anni dalla sua costituzione una struttura efficiente poiché supera la logica della relazione occasionale tra il mondo della ricerca ed il mondo delle imprese e favorisce una relazione costante fatta di sinergie per condividere le visioni di medio e lungo termine. In Campania siamo forti più nel settore della ricerca che in quello industriale.
Tra i nuovi progetti vanno segnalati la Urban Air Mobility, cioè la possibilità
di alleggerire il traffico e contrastare l’inquinamento
mettendo a disposizione degli aerotaxi che si muoveranno ad esempio tra gli aeroporti principali della Campania, come Capodichino e Pontecagnano, raggiungendo le mete senza intasare il traffico della città. Vi è poi il forte contributo alla svolta green nella ricerca della limitazione dell’inquinamento, soprattutto quello acustico, non solo le emissioni di carbonio, utilizzando materiali e processi di lavorazione riciclabili che richiedano poca energia.
In Campania la Tecnam ha avanzato un progetto di un aereo a propulsione elettrica, ma c’è anche grande interesse per il volo ipersonico, che coprirebbe la tratta Napoli – New York in un’ora e mezza.
Il distretto costituisce un luogo di discussione e di condivisione
che produce conoscenza di elevato impatto.
Purtroppo una parte troppo piccola di questa conoscenza si trasforma in innovazione a favore delle imprese e genera lavoro in maniera ampia a causa della ridotta dimensione delle imprese potenziali destinatarie. Si ritorna così al punto da cui si era partiti: la conoscenza è condizione necessaria per la crescita aziendale, ma non è sufficiente se non è integrata da un intervento pubblico efficiente e da una politica industriale attenta alle ragioni dello sviluppo di un territorio dalle notevoli potenzialità.