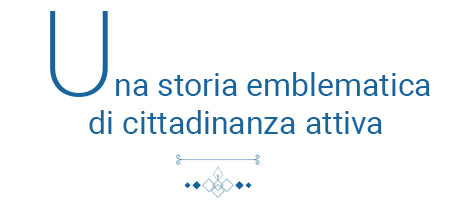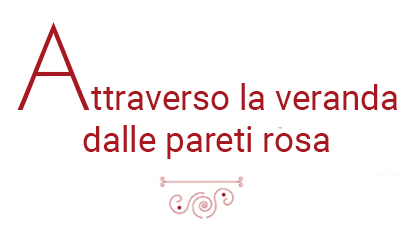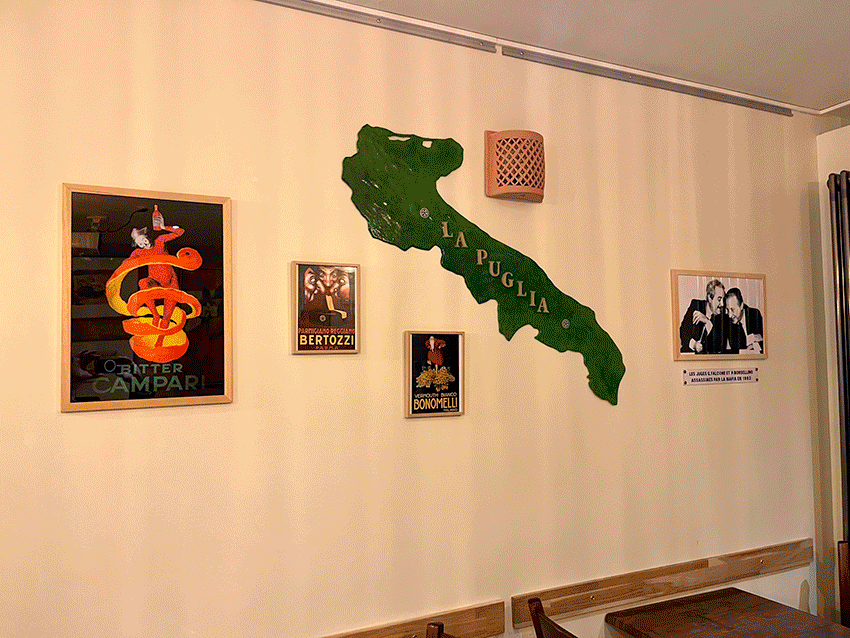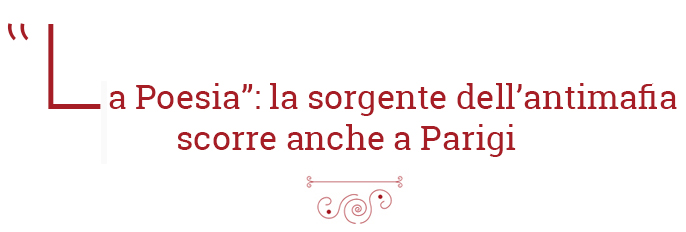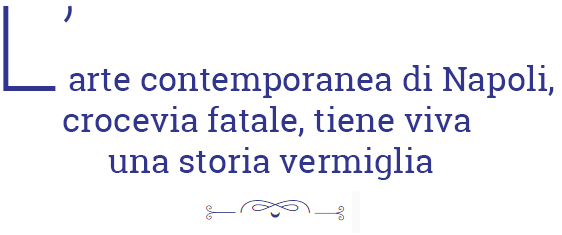CECILIO FRIOZZI DI CARIATI: IL PRINCIPE 007
Ma la realtà supera sempre la fantasia e infatti Cecilio, molto più dell’immaginario James Bond, univa in sé nobiltà, bellezza, fascino, intelligenza, spregiudicatezza, intuito ed una smisurata ricchezza personale. Egli fu l’ultimo erede dei titoli di Principe di Cariati, Principe di Montacuto, Duca di Castrovillari, Duca di Seminara, Marchese di Romagnano, Conte di Santa Cristina, Barone di Palmi e Barone di GarreriI, più una lunga sfilza di signorie minori, ma fu anche e, soprattutto, un avventuriero ed una spia.II
Cecilio nacque all’Ambasciata italiana di Pechino il 22 gennaio 1890,
dove il padre Lorenzo era Segretario di Legazione, mentre sua madre
Amata d’Ehrenoff era figlia del potente Ministro d
el Regno di Svezia e Norvegia in Cina
ultima rappresentante della sua antica e nobile famiglia, vedova in prime nozze di un Wallenberg, la più ricca famiglia svedese, il cui patrimonio ammonta a svariati miliardi di dollari.
Sin da bambino studiò in Inghilterra, presso il prestigioso Eton CollegeIII. Allo scoppio della Prima guerra mondiale lo troviamo in India, dove lavorava ufficialmente come ingegnere petrolifero, ma questa era solo una copertura: in realtà la sua carriera nello spionaggio era già brillante1.
Cecilio sapeva guidare ogni sorta di mezzo, dalle moto, alle auto, agli aeroplani, passando ovviamente per i carri armati, era appassionato
di corse automobilistiche e di equitazione,
nel 1915 brevettò l’innovativo “impermeabile Friozzi”IV, rivoluzionario per l’epoca, costituito da un quadrato di tela cerata foderato di lana, con un foro al centro per la testa, versatile ed utile sia per le corse a cavallo in quanto lasciava libere le braccia, sia come coperta da campeggio.
Il Principe di Cariati fu anche un grande seduttore e nel 1921 fu protagonista di un celebre scandalo dell’epoca, quando a Londra convolò a nozze con l’inglese Amelia Spratley-Johnson che per lui abbandonò a New York il figlio di sei anni e il primo marito, il barone polacco Maximilian Stanford de Sheyder-Shottland. Con lei si trasferì dapprima in Persia, lavorando presso una compagnia petrolifera anglo-persiana e, quindi, definitivamente in India, ma sfortunatamente da queste nozze non nacquero figli e la giovane Amelia morirà purtroppo in un incidente automobilistico nei pressi di Rawalpindi nel 1929.
Pochi anni dopo si risposò con l’inglese Grace Hampshire, anche se il matrimonio durò poco e decise così di rientrare in Europa verso la metà degli anni ’30, trasferendosi a Firenze nella villa che la famiglia possedeva e dedicandosi alla sua nuova passione: gli aeroplani.
Nel 1938 conobbe a casa della famiglia Rosselli del Turco una giovane italiana, Giulia Rio[ii], che sposò poco tempo dopo e da cui ebbe un’unica figlia, Vita, morta però a pochi mesi.IV
È proprio negli anni della Seconda guerra mondiale che la vita del Principe Cecilio inizia a prendere una piega ancora più avventurosa: convinto antifascista,
lasciò il suo Paese e venne arruolato, benché cittadino italiano,
presso il servizio segreto britannico.
Dagli archivi inglesi recentemente in parte desecretati scopriamo alcune missioni che lo videro protagonista, soprattutto in India, Estremo Oriente, Sud America, Tibet e nel Terzo Reich. Qui, nella Germania nazista sappiamo che si spacciava per un conte polacco e, insieme alla terza moglie, che gli fu abilissima complice col nome di Julia Chochoska, venivano invitati ad importanti ed esclusivi ricevimenti, dove scoprirono segreti, rubarono documenti e conobbero Adolf Hitler, correndo anche il rischio di venire scoperti e fucilati sul posto!
Durante la guerra venne catturato in India per presunte attività di spionaggio
in favore dell’Italia di cui comunque aveva mantenuto sempre la cittadinanza,
ma egli, mentendo spudoratamente, e grazie alla sua ottima conoscenza, tra le tante, anche della lingua inglese, convinse la polizia di non essere mai stato in Italia, di non parlare italiano e di essere un innocuo e mediocre ingegnere e fu rilasciato. A poco valsero gli allarmi che successivamente arrivarono da Londra e che lo definivano come un agente segreto straniero ‘pericolosissimo’ perché a quel punto l’astuto Cecilio era già lontano e al sicuro!
Tornò in Italia appena in tempo per assistere alla fine del Regno
e alla nascita della Repubblica e, nel febbraio del 1949,
lo troviamo a Firenze dove si occupò di liquidare
i suoi ultimi beni, per poi partire alla volta
del Pacifico meridionale,
dove visse fino alla morte, senza disdegnare altre sporadiche missioni in giro per il mondo a favore dell’Alleanza atlantica contro il totalitarismo sovietico, in omaggio alla sua forma mentis profondamente liberale.
Si calcola che alla sua morte il patrimonio di Cecilio Friozzi ultimo Principe di Cariati ammontava alla spropositata somma di ben 2000 miliardi di lire dell’epoca; ma il mistero che avvolse tutta la sua vita non lo abbandonò neanche dopo la morte, in quanto sembra che sua erede fu sua figlia Vita, la quale in realtà non era morta, ma venne dal furbo genitore spedita in America sotto falso nome per crescere ricca e al sicuro, lontana dai pericoli della Guerra mondiale.