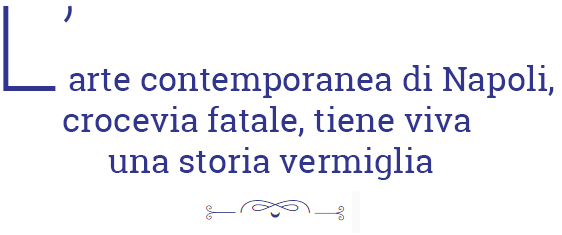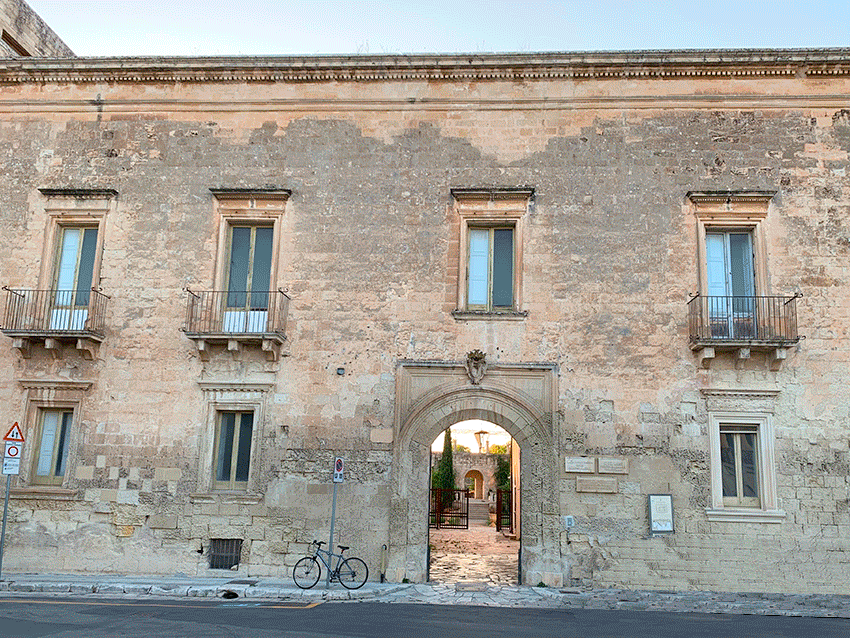Enrico Caruso è stato uno dei più grandi tenori di sempre e ha fatto conoscere e amare in tutto il mondo la lirica e la musica napoletana. La sua vicenda è narrata nel bel documentario “Enrico Caruso, the greatest singer in the world”, girato per i cento anni dalla morte dell’artista e prodotto dalla Direzione Generale per gli italiani all’Estero della Farnesina.
Caruso era di umili origini, ma sin da bambino maturò notevoli capacità musicali, tanto da suscitare l’attenzione di alcuni “maestri” dai quali prese lezioni, per quanto ancora di livello amatoriale. La dedizione che mise nello studio gli permise, nel tempo libero dal lavoro alla fonderia in cui il padre era operaio, di esibirsi presto in piccoli teatri e caffè fuori Napoli, cantando canzoni napoletane e arie d’opera. In una di queste occasioni venne notato dal baritono Edoardo Missiano che lo presentò al maestro Guglielmo Vergine, uno dei migliori maestri di canto della città. Quest’ultimo, intuendone il potenziale, accettò di dargli lezioni in cambio del 25% dei proventi che il tenore avrebbe guadagnato nei successivi cinque anni. Per il giovane venne poi la chiamata alle armi, ma la fortuna volle che un suo ufficiale, maggiore Nagliati, lo ascoltasse cantare in caserma. Rimanendo colpito dalla sua voce, non solo gli propose di andare a lezione dal suo amico barone Costa, ma fece anche in modo che il fratello di Enrico, Giovanni, lo sostituisse sotto le armi (la legge allora lo permetteva)!
Talento, professionalità e dedizione permisero a Caruso di debuttare nel marzo
del 1895, di farsi conoscere in Italia e di iniziare ad apparire sui giornali
Riuscì anche ad avere un’esperienza all’estero, percependo 600 lire per un mese di lavoro al Cairo. In quel periodo Caruso ebbe modo di conoscere direttamente il Maestro Puccini, che lo invitò nella sua casa di Torre del Lago. Il compositore stesso accompagnò Caruso al pianoforte e durante la romanza di Rodolfo, esclamò la famosa frase: “Chi t’ha mandato, Dio?”.
Fu proprio in quegli anni che iniziò una relazione con il soprano fiorentino Ada Botti Giachetti, per quanto già sposata e madre di un bambino, dalla quale ebbe poi due figli, Enrico jr. e Rodolfo. Per lei più avanti comprò Villa Bellosguardo a Lastra a Signa (presso Firenze, tuttora sede di un museo a lui dedicato). La loro unione finì undici anni dopo in tribunale, perché Ada lo lasciò per fuggire con l’autista. La coppia cercò anche di estorcere denaro al tenore.
Oltre all’Italia, Caruso iniziò a esibirsi all’estero con tournée in Russia,
a Lisbona, a Londra e a Buenos Aires. Aveva preso quota,
erano finiti i tempi dei localini di un tempo, ora in Italia cantava alla Scala di Milano, all’Opera di Roma, al Massimo di Palermo e al San Carlo di Napoli. Fu proprio qui, secondo la leggenda, che durante l’interpretazione de L’elisir d’amore nel dicembre 1901 si fosse così emozionato da aver subito delle incertezze canore; la protesta eccessivamente severa dei suoi concittadini e le critiche sui giornali gli fecero giurare di non cantare più nella sua città: sarebbe tornato solo per “vedere la mia cara mamma e mangiare i vermicelli alle vongole”. E così fu: un giuramento che Caruso manterrà per tutta la vita. Era pronto invece a cogliere il grande successo che lo attendeva oltreoceano.
Nel marzo del 1903, grazie al banchiere italiano residente a New York Claudio Simonelli, Caruso riuscì ad ottenere un eccezionale contratto con il Metropolitan Opera House. Simonelli, dopo lunghe trattative con il nuovo direttore Henrich Conried, era infatti riuscito a fargli accettare tutte le condizioni richieste dal tenore.
Il 23 novembre Caruso debuttò in un Metropolitan sfarzoso e brillante di luci.
In cartellone la sua opera preferita, Rigoletto.
Il pubblico era composto da alta società e giornalisti, Caruso era pronto e perfettamente all’altezza, ma la grande emozione lo fece muovere in maniera maldestra, tanto che ruppe il ventaglio del soprano Helen Mapleson. La serata non raggiunse picchi particolari di ammirazione, ma neanche di critica e risultò una serata “media”, come tante altre. La stampa comunque fu benevola, il New York Times mise in rilievo l’espressione e la flessibilità della sua voce, così come l’intelligenza e la passione sia nel canto che nella gestualità, mentre il Sun si rallegrava di come il nuovo tenore non mostrasse traccia del “tipico belato italiano” e faceva notare che Caruso era oltretutto un uomo piacente!
Al Rigoletto seguirono Aida, Tosca, Boheme, Pagliacci, Lucia, Traviata, Elisir d’amore, per complessive 29 recite in cui Caruso era sempre intento a reggere
e superare il confronto con Jean de Reszke, il tenore stabile del Metropolitan.
Era oltretutto un uomo affascinante e il pubblico femminile ne rimaneva ammaliato. Queste 29 serate furono le prime delle 607 realizzate per il Metropolitan, in ben diciassette stagioni.
Le rappresentazioni divennero sempre più veri e propri trionfi, la sua voce era considerata straordinaria. Durante un’esibizione il 5 dicembre lo straordinario successo fu sottolineato anche dall’inusuale gesto del soprano Marcella Sembrich, che raccolse uno dei fiori presenti sul palco e lo porse a Caruso.
Il tenore fu il primo ad incidere dei dischi sin dal 1902, e fu proprio questo supporto a contribuire alla divulgazione del mito. Oltretutto riuscì a vendere un milione di copie, diffondendo musica napoletana e operistica in tutti i continenti. E questo senza tralasciare l’impulso che le incisioni diedero all’aumento di ingaggi e cachet…
Nel 1910, diretto da Arturo Toscanini, Caruso cantò nella prima mondiale della Fanciulla del West di Giacomo Puccini. Era ormai diventato
il tenore più importante e famoso al mondo.
L’organizzazione di stampo mafioso La Mano Nera, con ramificazioni in Sicilia, tentò di estorcergli del denaro, sotto minaccia di morte. Caruso non cedette al ricatto e si affidò al poliziotto Joe Petrosino, che riuscì a far arrestare due dei tre delinquenti (e, grazie alle indagini, qualche anno dopo, anche due importanti capi della mafia newyorkese). Il tenore, alle estorsioni preferiva la beneficenza, soprattutto se riguardava gli immigrati italiani. Diede un concerto di beneficenza anche dopo l’affondamento del Titanic, a metà aprile 1912, e durante la I Guerra mondiale tenne concerti per i soldati.
Fino al 1920 la vita di Caruso era organizzata in base alle stagioni al Metropolitan,
alle incisioni discografiche, e ogni anno dalla primavera all’inizio dell’autunno
era in Europa (almeno fino allo scoppio della guerra),
ritagliandosi un mese estivo di vacanza italiana.
Durante le prove del Sansone e Dalila al Metropolitan crollò una scenografia in cartapesta, colpendo il tenore ad un fianco e fratturandogli le costole. Rimase sempre il dubbio se fosse un disgraziato evento del destino o un atto criminale. Le conseguenze dell’infortunio gli procurarono poi un’emorragia durante una rappresentazione che venne interrotta. Il 25 dicembre del 1920, mentre si trovava a Sorrento, il cantante lamentò forti dolori, che furono diagnosticati dai medici come pleurite infetta. Fu operato il giorno prima di capodanno.
Tornato in America, Caruso abbandonò le scene perché le sue condizioni erano particolarmente gravi. Decise poi di voler terminare i propri giorni a Napoli e con la moglie Dorothy (sposata nell’agosto del 1918), la figlioletta Gloria e il fratello Giovanni fece rientro in Italia.
Morì nella sua città, al Grand Hotel Vesuvio, il 2 agosto 1921.In occasione del centenario della morte, nell’abitazione dove nacque il cantante, è stato inaugurato il Museo Casa Natale Enrico Caruso.
Il tenore era estremamente legato a Napoli, la napoletanità rimase impressa
nella sua indole, nel suo carattere e temperamento fino alla morte.
Gli piaceva avere intorno napoletani, sia che fossero amici, collaboratori o colleghi. E questo perché lui stesso si sentì sempre profondamente napoletano, anche se il rapporto con la città fu caratterizzato da un’ambivalenza di struggimento e scetticismo.
Alcune delle canzoni napoletane incise da Caruso furono ideate e realizzate a New York, all’interno della comunità italiana, non a Napoli, come Core ‘Ngrato (scritta e musicata appositamente per lui), Tarantella sincera, Scordame, Sultanto a te, I’m’ arricordo ‘e Napule, ultima canzone incisa da Caruso nel 1920. Il 20 marzo 1916 aveva invece inciso la canzone Tiempo antico, scritta e musicata da lui stesso, una sorta di sfogo, di liberazione del suo amore per Ada perduto nel tempo.
Caruso fu in tutto e per tutto un italiano d’America, negli atteggiamenti, nell’allegria, nella passione, che lo portarono ad essere in tutto il mondo un vero, grande mito italiano.